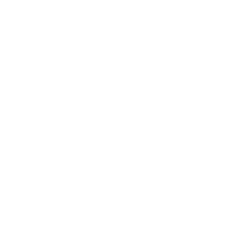Alla base di questi lapsus ci sono spesso dei pregiudizi di genere. L’uso linguistico poi non fa che registrare questi atteggiamenti, tanto che alcuni femminili di professione, benché perfettamente grammaticali, continuano ad essere poco attestati nell’uso. Quando si tratta però di validare le proprie teorie sui dati, le cose si fanno ben più complicate…
Il fatto stesso che ci sia stato un acceso dibattito pubblico sull’uso del femminile per designare le donne che ricoprono posizioni di prestigio o cariche istituzionali è indicativo di come i pregiudizi di genere permeino i nostri usi linguistici. Perché dovremmo chiamare una ministra ministro o una sindaca sindaco se non battiamo ciglio nell’usare il femminile per riferirci a un’infermiera o una cassiera? Non sarà forse perché in fondo pensiamo che quella posizione di prestigio si addice di più a un uomo che a una donna?
Dal canto suo, la lingua ci fornisce tutti gli strumenti necessari per la formazione dei femminili. Infatti, a mano a mano che le donne hanno iniziato a ricoprire ruoli più vari e di prestigio sociale più elevato, si sono iniziate a registrare nuove forme femminili (come magazziniera o architetta) o forme già esistenti hanno acquisito nuovi significati (ad esempio, avvocata). Tuttavia, alcuni femminili di professione, benché perfettamente formati, continuano ad essere poco attestati nell’uso (come medica) e ciò porta molte persone ad avere dubbi linguistici sul loro utilizzo.
Per capire come le nuove generazioni recepiscono questo dibattito, abbiamo deciso di osservare come studenti e studentesse di alcune scuole superiori italiane in Alto Adige denominano le professioni svolte dai propri genitori. Nella maggioranza dei casi, si riferiscono alle professioni svolte dalle loro madri usando il femminile, aderendo alla norma non solo per quanto riguarda forme ampiamente attestate, come cameriera, commessa, segretaria d’azienda, ma anche per quelle forme che nell’uso sono più frequenti al maschile, come poliziotta, imprenditrice, ragioniera (come attestato nel corpus CORIS); in altri casi, invece, si notano sia una certa creatività nell’espressione dei femminili di professione, come per imprenditora, sia segnali di dubbi linguistici per femminili non così frequenti nell’uso che danno luogo a combinazioni interessanti, come medico chirurga.
In 75 casi su 636, tuttavia, chi scrive descrive la professione di entrambi i genitori al maschile (uno è imprenditore e l’altro è bancario, oppure uno è operaio e l’altro addetto alle pulizie). Perché dunque viene utilizzato il maschile anche quando ci si riferisce a una donna? Caduta l’ipotesi della presenza di 75 coppie omogenitoriali maschili (a livello nazionale sono registrate circa 3000 persone con figli associate alle Famiglie Arcobaleno, di cui solo il 28% è di genere maschile), non sembra convincente una motivazione legata alla bassa frequenza di utilizzo dei corrispettivi femminili. Infatti, forme come operaia o addetta non sono infrequenti nell’uso della lingua, così come nei nostri dati, eppure vengono evitate. Una motivazione legata al prestigio sociale potrebbe spiegare l’uso di alcuni maschili, imprenditore al posto di imprenditrice o bancario al posto di bancaria, ma nei nostri dati troviamo anche impiegato al posto di impiegata, operaio anziché operaia: anche questa motivazione non sembra essere del tutto sufficiente. In attesa di ulteriori riscontri e analisi, chiediamo a voi che ci leggete: che cosa spinge, secondo voi, studenti e studentesse a evitare l’uso del femminile nei nomi di professione?


Tags
Citation
This content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except for third-party materials or where otherwise noted.

Kann man den Genderstern in andere Sprachen übersetzen?
 Elena Chiocchetti
Elena Chiocchetti
Is English shoeing out smaller languages from many specialised domains?
 Elena Chiocchetti
Elena Chiocchetti
Interpretieren mehrsprachige Menschen Aussagen anders, als sie gemeint sind?
 Sophie Braterschofsky
Sophie Braterschofsky