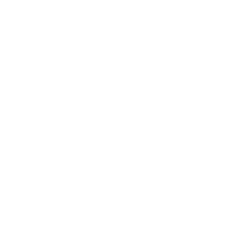Possiamo vivere senza funerali?

Come il lockdown ci ha fatto riflettere sull’importanza dei riti di passaggio per i singoli individui e per la società intera. Un excursus antropologico di Claudia Lanzidei.
La pandemia da Covid-19 è arrivata, in Italia come nel resto del mondo, in maniera quasi del tutto inaspettata, mettendo il genere umano di fronte all’inevitabile necessità di affrontare una crisi spietata su più fronti e di guardare in faccia quella che rappresenta probabilmente la più grande paura per tutti: la morte. Purtroppo, un aumento vertiginoso della mortalità in moltissime aree italiane è coinciso con l’impossibilità, durante i mesi di picco dell’epidemia, di celebrare i funerali. Difatti, come da decreto ministeriale, al defunto era concessa la sola presenza di un paio di parenti stretti che lo accompagnassero nel luogo di sepoltura: non una celebrazione religiosa, né l’ultimo saluto di amici e altri cari. Questa situazione di negazione del momento rituale, per quanto giustificata dalla necessità di evitare assembramenti al fine di ridurre e contenere quanto più possibile l’epidemia da Covid-19, ha messo in luce l’importanza, spesso trascurata, delle pratiche culturali e sociali.
A questo proposito, è interessante riflettere su quello che è successo in Italia e sulle infrazioni che non sono mancate. Un episodio, condiviso mediaticamente e divenuto noto probabilmente a tutti gli italiani, risulta particolarmente emblematico in questo senso. Il 19 aprile 2020, a Saviano, nel napoletano, un numero insolitamente alto di persone è sceso in strada, nonostante i divieti, per accompagnare il feretro del sindaco, morto di Covid-19. Il sindaco, che era anche chirurgo all’Ospedale di Nola, è stato un personaggio molto amato e benvoluto dai cittadini di Saviano, ma la legge dovrebbe parlare chiaro sulle regole da adottare contro il virus, e così dovrebbe fare anche l’amor proprio e la paura di ammalarsi dei cittadini stessi. La decisione di molti di scendere in strada non è sembrata pertanto dettata dalla logica, e rimane sicuramente una scelta sanzionabile legalmente e altamente rischiosa per la propria salute. Cosa può aver portato tante persone a correre un pericolo tale? La risposta sta probabilmente nel valore sociale e culturale dei riti funebri.
Monete sugli occhi, tabù non rispettati e pianti disperati: i funerali esprimono cultura
I rituali funebri non sono altro che pratiche sociali, comuni a tutto il genere umano, anche se molto diversi fra loro a seconda del contesto culturale e storico. Se nella Grecia antica due monete venivano poste sugli occhi del defunto per permettergli di pagare al traghettatore Caronte il passaggio all’oltretomba, a Cuba i praticanti delle religioni afro-cubane non possono prescindere dal compiere il rito chiamato Itutu, che permette di stabilire se la morte sia avvenuta al momento giusto o se sia stata causata dal fatto che la persona non abbia osservato i tabù impostigli dalla divinità alla quale era stata iniziata in vita. In Basilicata fino agli anni cinquanta del secolo scorso, le prefiche, o “piagnone”, venivano ingaggiate a pagamento durante la veglia al defunto per piangere in maniera straziante, strappandosi anche i capelli, al fine di accentuare la tragicità della morte nonché la fragilità della vita, mentre in Val Gardena era in uso fra due amici stabilire una “fratellanza di messa”, per cui chi dei due fosse sopravvissuto all’altro lo avrebbe omaggiato con una messa commemorativa. Il rituale funebre rispecchia, pertanto, il modo in cui la morte e il lutto vengono interpretati culturalmente da un determinato gruppo in un determinato contesto.
Antropologicamente definiti, gli esseri umani sono infatti composti tanto di natura quanto di cultura: quest’ultima, intesa come insieme di pratiche, è ciò che distingue il genere umano dagli altri animali. Come afferma l’antropologo Francesco Remotti, la cultura è elemento creato dall’uomo ma anche creatore dell’uomo, senza il quale l’essere umano non potrebbe definirsi tale: essa infatti, nelle sue diversissime varietà, permette alla natura (in senso biologico) di diventare umana, di acquisire umanità. Inoltre, la cultura è socialmente condivisa da un gruppo di essere umani, i quali la esprimono attraverso un insieme di pratiche, vive e significative all’interno del gruppo.
Antropologicamente definiti,
gli esseri umani sono composti tanto di natura quanto di cultura – Francesco Remotti –
Quel momento nel limbo
Diversi antropologi hanno avuto modo di studiare da vicino i rituali funebri, in diversi angoli di mondo e analizzandoli da varie prospettive e punti di vista. Uno dei più celebri studiosi e teorici in quest’ambito è stato Arnold Van Gennep, il quale più di mezzo secolo fa teorizzò i cosiddetti “riti di passaggio”, elemento ancora oggi importante per lo studio antropologico dei rituali. Sotto questo nome Van Gennep racchiuse tutti quei rituali che segnano momenti critici, di passaggio da uno status all’altro, nella vita dell’individuo: nascita, passaggio dalla pubertà all’età adulta, matrimonio e morte. Il contributo più prezioso degli studi di questo antropologo consiste nell’aver teorizzato l’esistenza di una fase liminale, dettata dal rituale stesso. In questa fase, l’individuo non è più nello stato che si sta lasciando alle spalle, e neanche in quello verso il quale si sta dirigendo: si può dire, piuttosto, che si trova nel limen (dal latino: soglia, confine) fra i due. Durante questa fase di transizione la vita ordinaria è momentaneamente sospesa e l’individuo si prepara a essere socialmente pronto per il suo nuovo status, per la sua nuova esistenza sociale. Si tratta di un momento di transizione, in cui la separazione da quello che si era è già avvenuta, mentre l’incorporazione in ciò che si è in procinto di essere non ha ancora preso forma.
La doppia sepoltura della tribù dei dayak
Un altro studioso il cui contributo è stato fondamentale per lo studio della morte e del lutto in ambito antropologico è stato Robert Hertz. Già molto prima di Van Gennep, nel 1907, il sociologo francese analizzò il rituale della doppia sepoltura praticato dai dayak del Borneo (Indonesia). Questo rituale prevedeva che il defunto venisse sepolto due volte, con una distanza di tempo fra la prima e la seconda sepoltura che poteva variare dagli otto mesi ai sei anni. Questo lasso di tempo era necessario per la decomposizione del corpo, e rappresentava per i vivi un periodo di rinunce, pericoli e paure. Tutti gli oggetti del defunto venivano distrutti o resi dei taboo, mentre i famigliari dovevano portare i pasti sul luogo di sepoltura giornalmente, come se il defunto fosse ancora in vita. Questo periodo liminale, di decomposizione del corpo, era anche momento di transizione per l’anima, la quale era a rischio e non avrebbe potuto accedere al regno dei morti fino alla conclusione del rituale. Anche per i famigliari questo arco di tempo era caratterizzato da precarietà, pericolo, e stravolgimento del quotidiano per via di numerosi obblighi e divieti: ad esempio, essi non potevano lasciare il villaggio, e non potevano mangiare le stesse pietanze o vestirsi allo stesso modo degli altri abitanti. La cerimonia finale, la quale coinvolgeva l’intera comunità e sanciva la fine dello stato liminale, aveva tre scopi principali: dare degna sepoltura ai resti del defunto, permettergli di entrare a pieno titolo nel mondo degli antenati e liberare la sua famiglia dal lutto, permettendole di ritornare alla vita quotidiana.
Questi studi antropologici sulla morte potrebbero essere un prezioso spunto di riflessione per comprendere le motivazioni intrinseche che hanno spinto quasi tutti gli abitanti di Saviano a trasgredire alle regole, esponendosi al pericolo. Gettano infatti luce sull’importanza strutturale della pratica rituale e culturale, della quale ci siamo accorti nel momento esatto in cui ci è stata negata. Forse Hertz aveva ragione nel dire che, in fondo, i rituali funebri e il lutto rappresentano, ognuno dalla sua particolare prospettiva, un tentativo di vincere la morte e far persistere la vita. La vita dell’individuo, ma soprattutto quella della comunità che, affrontando ritualmente la morte del singolo, riesce a elaborarla e comprenderla, e a ribadire così la propria vitalità e resilienza. Sancire ritualmente la morte di un individuo all’interno della comunità è quanto mai importante per superare la fase liminale, accettare la morte e la perdita a livello individuale e collettivo, e tornare alla vita.
 | Claudia Lanzidei è antropologa culturale con un Master of Science all’Università di Copenhagen, lavora come trainee al Center for Advanced Studies di Eurac Research. Per la sua tesi ha condotto ricerca sul campo a Cuba, occupandosi della dimensione rituale delle religioni afro-cubane note come santería e spiritismo. Durante il lock-down ha scoperto il piacere di coltivare il suo piccolo orto sul terrazzo, ma spera nel prossimo futuro di tornare a Cuba per il dottorato. |
Citation
This content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except for third-party materials or where otherwise noted.