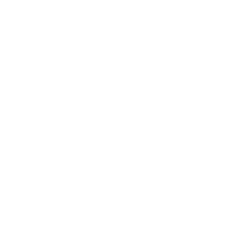Migrazioni, agricoltura e sviluppo rurale

Nel volume Migration, Agriculture and Rural Development, Domenica Farinella e Michele Nori esplorano le connessioni tra migrazioni internazionali, sviluppo rurale e giustizia sociale. Il libro connette processi globali con dinamiche di sviluppo locale, invitando a interpretare le migrazioni contemporanee da e verso le zone rurali “in relazione all'incorporazione dei sistemi agricoli nei mercati globali, alla governance agricola e alla lotta dei territori locali tra innovazione e resilienza".
Frutto di un’ampia ricerca svolta dal 2014, il volume approfondisce le dinamiche specifiche dei sistemi agricoli di Italia, Grecia e Spagna. Un’intervista con gli autori.
In che modo i cambiamenti in atto nel mondo della produzione agricola si intrecciano con la presenza straniera nelle aree rurali europee?
Farinella: Per rispondere alle richieste di un mercato globale sempre più incentrato sul cibo a basso costo, negli ultimi decenni la produzione agricola si è intensificata ed è sempre più assorbita dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Si parla di una vera e propria ristrutturazione delle catene globali dell’agri-food. Si è così assistito all’intensificazione dello sfruttamento dei due principali fattori produttivi: terra e lavoro.
In questo quadro, la crescente richiesta di forza lavoro nelle regioni meridionali d’Europa non trova risposta nella manodopera locale, nonostante gli elevati livelli di disoccupazione e inattività. Questo ha creato un’offerta per i lavoratori migranti. Può sembrare un paradosso, ma si spiega considerando alcune caratteristiche dell’agricoltura e del mercato del lavoro dei paesi dell’Europa del Sud. Da un lato, l’agricoltura è un settore tipicamente manuale e, soprattutto nelle aree meridionali, con un livello di meccanizzazione limitato. In altre parole: alta intensità di lavoro e bassa produttività. Si genera così quella che William Baumol ha chiamato “malattia dei costi” che intrappola le attività manuali in bassi salari, poco appetibili per le popolazioni locali. Dall’altro, come suggeriva già negli anni Settanta la teoria dualistica del mercato del lavoro, la segmentazione del mercato del lavoro. Ecco allora che vi si trovano una “forza lavoro centrale”, garantita e protetta, e segmenti più o meno estesi di “lavoratori periferici e marginali”, soggetti a una forte precarizzazione, informalità, bassi salari e scarsa protezione, soprattutto nei comparti manuali come appunto agricoltura, servizi e commercio.
È in questo contesto altamente ambivalente che la presenza dei migranti in agricoltura si è fatta sempre più visibile. Da un lato i migranti rappresentano un segmento della forza lavoro “disposto” ad accettare salari e condizioni lavorative che altri rifiutano, dall’altro per essi l’agricoltura rappresenta una porta d’accesso, anche se precaria, al mercato del lavoro europeo e una qualche forma di guadagno.
Soprattutto nel caso di lavoratori informali migranti, il lavoro in agricoltura è al contempo un’opportunità e una trappola. Questa ambivalenza genera una grande mobilità: l’agricoltura è spesso un settore di ingresso, ma rappresenta un lavoro temporaneo, dal quale si tende a spostarsi in comparti in cui le condizioni di lavoro e le paghe siano migliori non appena ve ne sia la possibilità. In alternativa, ci si muove da un posto all’altro anche nello stesso ambito agricolo, come testimoniano le numerose ricerche sociologiche condotte negli ultimi anni. D’altronde, se i salari e le condizioni di lavoro e di vita nelle campagne non migliorano, non resta che abbandonare non appena possibile.
Questa è senza dubbio la sfida da affrontare per il futuro. Se davvero si vuole trasformare il lavoro agricolo in un progetto di vita in cui investire e non una trappola temporanea da cui fuggire non appena possibile, sia per stranieri che per i locali, bisogna lavorare seriamente sulla sua qualità e, contemporaneamente, sulla qualità della vita rurale che oggi è ben lontana da quell’immaginario bucolico e romantico di cui sono infarciti i racconti sul mitologico ritorno dei giovani alla campagna.
In questo senso, la strategia per le aree interne avviata qualche anno fa da Fabrizio Barca sembrava rappresentare un punto di svolta, perché guardava in modo integrato ai piani dell’efficienza economica e dell’inclusione sociale nelle aree rurali, considerando l’importanza strategica di rafforzare i servizi essenziali che rendono attrattivo un territorio e migliorano la qualità della vita degli abitanti. Purtroppo, l’attuazione di questa strategia è andata a rilento, anche forse per una certa miopia da parte della politica nazionale.
La vostra ricerca si concentra sui contesti rurali più marginali, dove il potenziale di intensificazione agricola è strutturalmente limitato. Quali sono le sfide specifiche che riguardano queste aree?
Nori: Nelle regioni di pastori – di per sé molto diversificate tra loro in quanto comprendono isole, montagne, drylands – il problema del ricambio generazionale è più grave che altrove e le implicazioni ambientali, ma anche sociali e culturali, sono maggiori. Inoltre, la pastorizia è un settore poco considerato e maltrattato dalle politiche agricole, quindi le forme di sostegno della politica, ma anche della tecnologia e delle dinamiche commerciali, non hanno contribuito a migliorare questa forma di vita e di lavoro. Diventa quindi ancora più difficile trattenere i giovani e attrarne di nuovi.
Se davvero si vuole trasformare il lavoro agricolo in un progetto di vita in cui investire e non una trappola temporanea da cui fuggire non appena possibile, sia per stranieri che per i locali, bisogna lavorare seriamente sulla sua qualità e, contemporaneamente sulla qualità della vita rurale che oggi è ben lontana da quell’immaginario bucolico e romantico di cui sono infarciti i racconti sul mitologico ritorno dei giovani alla campagna.
Alle pratiche pastorali è dedicato un intero capitolo del libro. In che modo questo settore incorpora e ridefinisce il ruolo dei nuovi arrivati nelle aree rurali?
Nori: Proprio gli immigrati hanno fino a oggi riempito questo vuoto generazionale; certo, le conoscenze non sono sempre quelle appropriate e necessarie, ma su questo si può lavorare. Le esperienze che si stanno sviluppando di scuole di pastori sono buoni esempi al riguardo. Ma anche la politica deve fare la sua parte. Con il quadro economico e legale a oggi vigente, la scarsa integrazione dei lavoratori stranieri in ambienti rurali non permette il loro passaggio da pastori ad allevatori, né tantomeno incoraggia l’evoluzione da lavoratori a imprenditori, contribuendo così al ricambio generazionale. Come già avvenuto in altri momenti storici, in cui a un ricambio generazionale si è sovrapposto anche uno geografico, come il caso dei pastori sardi arrivati in Toscana e Lazio a metà Novecento.
In che modo le comunità immigrate possono contribuire alla resilienza delle aree rurali?
Nori: Le comunità immigrate a oggi già contribuiscono alla resilienza delle aree rurali perché molti mestieri locali, tra i quali quello dei pastori, ma anche i mestieri forestali e quelli edili, in queste aree vengono svolti da stranieri. Inoltre, l’assistenza domestica agli anziani rimasti nei paesi rurali è spesso appannaggio di assistenti familiari di origini straniere. Le famiglie straniere, mediamente più giovani e numerose della media italiana, spesso abitano in aree di periferia o rurali. I loro figli permettono di rimpolpare la demografia locale e di mantenere attivi servizi di base. Alcuni di questi processi sono descritti in alcuni articoli piuttosto recenti ai quali abbiamo contribuito; tra questi, segnalo in particolare i testi scritti con Daniela Luisi, disponibili sia in lingua inglese che in italiano, che considerano nello specifico la popolazione straniera residente nelle aree interne italiane, mettendo in evidenza le potenzialità di interazione tra lo sviluppo locale e i nuovi abitanti nel quadro delle politiche pubbliche territoriali.
Farinella: Io penso che in generale vi sia ancora una scarsa attenzione alle potenzialità di una inclusione attiva delle popolazioni straniere nelle aree rurali. Il dibattito pubblico tende spesso a ridurre i migranti alla figura monodimensionale del bracciante, dimenticando che sono prima di tutto persone che abitano le nostre campagne e i nostri paesi: li abitano generosamente, come ad esempio quegli uomini e donne che assistono i numerosi anziani residenti. Li abitano a volte per scelta, altre volte forzatamente. Alcune esperienze di SPRAR e CAS, ad esempio, sono state ubicate nelle zone più interne con la malsana idea che per risolvere lo spopolamento di queste aree bastasse obbligare un po’ di richiedenti asilo senza alcuna voce in capitolo a stare là per un po’. Un'idea che ovviamente sottende la volontà di invisibilizzarli, spostandoli in zone rurali a bassa densità abitativa che possono essere narrate come “vuote”, non abitate, naturali. Uno spazio che non serve insomma, di cui il decisore pubblico può disporre senza porsi il problema di chi alla fine lo abita, invisibilizzato pure lui. In ogni caso sono persone che abitano, vivono, lavorano, creano relazioni, fanno in qualche modo famiglia e questo deve essere considerato sempre e comunque quando di loro si racconta.
Nel vostro libro definite la migrazione internazionale verso le regioni rurali d'Europa come un fenomeno "super diversificato", richiamando l'espressione di Vertovec (2007). La superdiversità nelle aree rurali può contribuire a decostruire l'idea di un mondo rurale statico?
Farinella: Fin qui abbiamo parlato di lavoratori migranti come se fossero un unicum indistinto, ma in realtà questo non rende giustizia alla complessità del fenomeno. Da un lato si registrano in continuazione processi di spiazzamento della manodopera migrante, per cui alcuni gruppi migratori sostituiscono gli altri in determinati momenti, come ad esempio è accaduto nel caso della pastorizia sarda, in cui le prime ondate di operai albanesi, dagli anni Novanta in poi, sono state sostituite negli anni duemila da lavoratori romeni e più di recente da indiani e nord-africani. È quindi un errore parlare genericamente di “migranti”, senza considerarne i percorsi e le reti migratorie, le differenti culture e soggettività, ma soprattutto le conseguenti diverse progettualità che vengono messe in campo nella pratica dell’esserci sul territorio. In questo senso, troppo spesso i migranti sono “narrati” attraverso una immagine passiva, in cui essi subiscono lo sfruttamento e l’informalità, senza prestare adeguata attenzione al modo in cui essi riescono ad attivarla a proprio vantaggio, spostandosi da un’attività all’altra e mettendo in campo strategie di sopravvivenza, di diversificazione e integrazione del reddito che sfruttano di volta in volta le reti relazionali, le opportunità del sistema di welfare e delle politiche pubbliche, il valore che si genera da attività di riproduzione e autoconsumo, e così via.
Sono questi aspetti che emergono chiaramente ad esempio se si guarda al contributo degli operai romeni nella pastorizia sarda in alcuni lavori da me realizzati con il collega antropologo Sebastiano Mannia.
D’altra parte, il tipo di lavoro, le forme di organizzazione e di insediamento sul territorio, il genere, così come le capacità di attivazione sono variegate, diversificate e necessitano approfondimenti specifici che non possono essere semplificati nel solo schema del caporalato, che pure è stato molto importante nel dibattito sul lavoro migrante in agricoltura. Noi, con la nostra ricerca sui migranti che lavorano nella pastorizia estensiva tipica delle aree rurali più interne, abbiamo voluto mostrare una faccia meno conosciuta dell’essere migrante nella campagna. Il lavoro del pastore si svolge in solitudine, in zone impervie, in cui diventa difficile scorgerne la presenza; si svolge durante tutto l’anno, non si concentra nei mesi di raccolta, è duro ma lo è in modo profondamente differente dal lavoro bracciantile stagionale, e la fatica è aggravata dalla solitudine.
Altre ricerche hanno mostrato le peculiarità del lavoro di serra o ancora la capacità di alcuni gruppi di lavoratori migranti di costruire percorsi di lotta per il riconoscimento dei diritti e per una paga giusta, mostrando come proprio da lavoratori marginali e subalternizzati possano partire importanti processi di rivendicazione sociale e lavorativa, come suggeriva in un libro inchiesta di qualche anno fa, Antonello Mangano. Si tratta di percorsi che sono poi sfociati anche in esperienze agricole cooperative innovative, in cui si sono uniti diversi know-how e si è creata una collaborazione tra manodopera locale e migrante all’interno di filiere agricole “etiche”. Basti qui ricordare nel caso italiano, i percorsi di lotta sindacali che sono poi confluite nell’associazione NO CAP avviata da Yvan Sagnet con il progetto SfruttaZero, o nel movimento degli invisibili, promosso da Aboubakar Soumahoro.
Il libro prova a raccontare, con un lavoro di rassegna, alcune di queste esperienze per restituire il variegato caleidoscopio della presenza migrante nelle aree rurali e provare a stimolare qualche domanda nel lettore su come “farsi carico” e “restituire” tale complessità.
La presenza straniera, d’altronde, non si limita soltanto al lavoro, anche se nel dibattito pubblico è spesso funzionale ridurla soltanto a questo, perché permette di oggettificare e compartimentare i migranti in lavoratori, lavoratori che restano di “seconda classe” perché hanno diritto di esistenza soltanto fintanto che “servono” alla produzione e devono magicamente “scomparire” quando questa si è conclusa. Questo è stato evidente durante il lockdown provocato dall’emergenza pandemica: all’improvviso si è scoperto quanto importanti fossero i lavoratori migranti. Il dibattito si è tutto incentrato sul come garantire il rifornimento di beni agricoli, proponendo come misure vergognosi “permessi soggiorno temporanei”, validi giusto il tempo di non fare inceppare la macchina produttiva, senza spendere alcuna parola sul diritto alla vaccinazione per queste persone o a condizioni di lavoro che li tutelassero dalla malattia.
In che modo la riforma della politica agricola comune ha dato spazio e riconoscimento alla presenza straniera nelle aree rurali?
Farinella: Potremmo dire in nessun modo o forse, per essere generosi, in modo molto limitato. La politica agricola comune, nonostante negli ultimi anni abbia adottato un approccio orientato allo sviluppo rurale, al concetto di multifunzionalità agricola e alla capacità dell’agricoltura di fare paesaggio, fatica ancora a valorizzare in concreto i paesaggi rurali storici e la loro biodiversità. Questo perché è stritolata da un mercato europeo in cui un ruolo dominante e lobbistico continua a essere svolto dall’industria dell’agri-food e dalle sue corporations.
Le politiche europee sono da questo punto di vista contradditorie: da un lato si incentivano misure che assegnano un ruolo ecologico all’agricoltore, spingono verso la de-intensificazione e la biodiversità culturale e ambientale; dall’altro le politiche sulla concorrenza non riescono davvero a sanzionare le diffuse pratiche di concorrenza sleale e opportunismo. Tra queste pratiche rientrano, per capirci, le aste al ribasso praticate dalla Grande Distribuzione Organizzata, che spingono l’agricoltura verso l’intensificazione. Ne fanno parte anche i processi di standardizzazione e certificazione che spingono in modo paradossale verso una maggiore industrializzazione dell’agricoltura nonché la convenzionalizzazione del biologico, ponendo fuori mercato proprio quelle piccole imprese agricole familiari contadine che la nuova politica agricola comune sostiene di voler valorizzare.
In questo quadro già così contradditorio, non ci sembra vi sia stata una particolare sensibilità per riconoscere e valorizzare la presenza straniera nelle aree rurali.
Domenica Farinella
Domenica Farinella è docente di sociologia economica e sociologia della globalizzazione all'Università di Messina. Ha conseguito un dottorato di ricerca in sociologia dei processi di innovazione presso l'Università di Napoli Federico II. I suoi interessi di ricerca includono studi rurali e locali con particolare attenzione ai cambiamenti nella pastorizia, alla multifunzionalità in agricoltura, all'economia informale e alla questione meridionale. Negli ultimi anni ha condotto ricerche etnografiche sulle catene di valore del latte ovino e sui cambiamenti nella pastorizia sarda e ha esplorato il ruolo dei sistemi di welfare nelle aree rurali.
Michele Nori
Michele Nori lavora al Global Governance Programme dell'European University Institute (EUI) di Firenze. Agronomo tropicale di formazione, con un dottorato in sociologia rurale, ha lavorato a lungo in aree pastorali in Africa, Asia e nella regione mediterranea. Ha recentemente completato una borsa di studio Marie Curie, studiando il ruolo dei pastori immigrati per la sostenibilità dei sistemi pastorali nei paesi mediterranei dell'Ue. Attualmente è impegnato nel progetto PASTRES, finanziato dall'ERC, che studia le interfacce tra pastorizia, resilienza e incertezza.

Citation
This content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except for third-party materials or where otherwise noted.

‘I confini più duri del mondo sono fatti di carta’: Migranti senza documenti e società civili a Rotterdam
 Giorgia Zogu
Giorgia Zogu
Dolomìa: a digital platform for migrant associations in South Tyrol




Closing borders is supposed to create a sense of security for those within. (…) ‘protecting’ borders also suggests that there is something to be protected from.
 Verena Wisthaler
Verena Wisthaler