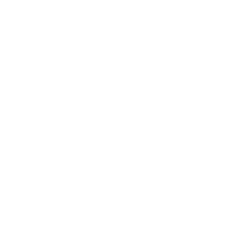magazine_ Article
La scienza può spiegare l’alpinismo?
Studi sulla fisiologia umana hanno da sempre supportato le grandi imprese alpinistiche cercando di predirne i limiti. Spesso sono stati smentiti dai fatti.
Il medico Chris Pizzo, membro della American Medical Research Expedition to Everest (AMREE), preleva campioni di gas alveolari da se stesso in cima al Monte Everest. È il 1981.
Negli anni Cinquanta, quando l’interesse per gli Ottomila cresceva in tutto il mondo, la conoscenza della fisiologia umana a quote estreme era in realtà assai scarsa. Alle poche informazioni raccolte sul campo si tentava di ovviare con esperimenti in laboratorio e ipotizzando proiezioni. Nei decenni successivi, arditi studi medici in quota raccolsero dati sempre più dettagliati. Ancora oggi si cerca il test perfetto: i fattori fisiologici predittivi della riuscita di un’impresa in quota. Solitamente però sono state le spedizioni alpinistiche a rivoluzionare le opinioni scientifiche.
È possibile raggiungere la cima all’Everest – a 8848 e rotti metri sul livello del mare – senza utilizzare ossigeno supplementare? L’altoatesino Reinhold Messner e l’austriaco Peter Habeler avevano già risposto pragmaticamente nel 1978 con la prima, incredibile ascesa senza bombole che cambiò la storia dell’alpinismo. Ma ancora negli anni Ottanta, era questa la domanda regina che tormentava chi praticava l’alpinismo e chi studiava il funzionamento del corpo umano a quote estreme. Dal punto di vista scientifico l’ossigeno supplementare sembrava essere fondamentale e l’impresa del 1978 era considerata una sorta di inspiegabile eccezione.
La scienza dell’altitudine era ancora nelle sue fasi preliminari. Qualche decennio prima, nel secondo dopoguerra, gli Ottomila erano ancora un territorio del tutto inesplorato, sia dal punto di vista alpinistico che scientifico. Non c’erano dati e la conoscenza delle reazioni del corpo umano a quelle quote era pressoché nulla. Ciò che si tentava di fare era elaborare delle proiezioni basate sulle rare misure a disposizione. Un’alternativa era simulare la quota in un laboratorio.
Uno dei primi esperimenti in questo senso avvenne nel 1946 all’interno della Naval Air Station, una minuscola camera ipobarica in acciaio situata a Pensacola, in Florida, e gestita dalla marina degli Stati Uniti d’America. Quattro alpinisti furono portati a 8846 metri di quota in 33 giorni, raggiungendo anche i 15.000 metri per qualche minuto – furono seguiti da una corposa squadra composta da una quarantina di persone tra personale medico, meccanico e tecnico. Lo studio divenne noto come Operation Everest I: l’obiettivo era quello di studiare i cambiamenti fisiologici nel corpo umano in altitudine con e senza ossigeno supplementare. Per la prima volta un corpo umano raggiungeva quelle quote e per la prima volta le conseguenze dell’altitudine – come l’ipossia, ovvero la mancanza di adeguato ossigeno nel nostro organismo – potevano essere monitorate e valutate da personale scientifico, seduto comodamente al di fuori della camera di simulazione.
Qualche anno più tardi, nel 1953, arrivò invece il momento di portare per la prima volta l’essere umano in cima all’Everest – per davvero. E per lo studio della fisiologia rappresentò una preziosa occasione per misurare dati mai raccolti prima sul campo.
La fisiologia della prima ascesa dell’Everest
Nel 2023 abbiamo celebrato i 70 anni dalla prima ascesa del monte Everest ad opera del neozelandese Edmund Hillary e dello sherpa nepalese Tensing Norgay. La vetta più alta del mondo fu conquistata il 29 maggio 1953. Sir Edmund Hillary era personalmente molto interessato agli studi sulla fisiologia umana; alla spedizione partecipò inoltre un fisiologo di professione: il britannico Griffith Pugh. Griffith Pugh per la prima volta poté raccogliere informazioni , sul campo e in quota, che riguardavano la respirazione e sulla fisiologia dell’essere umano ad altitudini estreme. Si trattava di dati pionieristici.
Secondo i principali fisiologi dell’epoca – e tra questi anche Griffith Pugh – la cima più alta della Terra non era raggiungibile senza l’ausilio di ossigeno supplementare. Piuttosto la domanda che si pose Griffith Pugh prima della partenza della spedizione riguardava le quantità: di quanto ossigeno ausiliario ha bisogno il corpo umano lassù?
Per capirlo, Griffith Pugh estrapolò delle proiezioni basandosi sui dati a sua disposizione. Vennero prese in considerazione la pressione barometrica attesa in vetta e il massimo consumo di ossigeno degli alpinisti. Quest’ultimo parametro, denominato VO2max, esprime quanto ossigeno viene consumato per ogni contrazione muscolare. In soldoni: la potenza aerobica dell’individuo.
Prima della partenza, il massimo consumo di ossigeno di Edmund Hillary fu misurato in due occasioni, al livello del mare – più precisamente a Oxford, mentre l’alpinista correva su di un tapis roulant – e a 4000 metri di quota. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, i valori di Hillary non erano eccezionali. Secondo i suoi calcoli, Griffith Pugh decise quindi che i due alpinisti avrebbero dovuto portarsi dietro alcuni pesanti cilindri che erogavano fino a quattro litri di ossigeno al minuto.
I dati raccolti durante la prima ascesa sull’Everest e in spedizioni successive rafforzarono l’idea che sugli Ottomila l’ossigeno supplementare fosse assolutamente necessario.
 technical documentation
technical documentationQuanto è importante il fattore VO2max?
Un recente paper scientifico ha analizzato i dati fisiologici raccolti prima, durante e dopo alcune delle storiche ascese dell’Everest: la prima ascesa di Edmund Hillary e Tensing Norgay del 1953, l’impresa compiuta senza ossigeno supplementare da Reinhold Messner e Peter Habeler del 1978, studi scientifici come AMREE e l’operazione Everest II. Gli autori hanno confrontato i dati storici con gli standard fisiologici dell’epoca e con quelli attuali. Durante le ascese storiche, il parametro considerato centrale per valutare l’esigenza di ossigeno supplementare è il VO2max, il flusso massimo di ossigeno che sotto sforzo arriva dall'aria ambiente ai mitocondri attraverso l'intero sistema respiratorio.
Il paper osserva come solo a partire dagli anni Novanta, l’importanza di questo parametro è stata ridimensionata. Ampie differenze del valore VO2max a livello del mare – ad esempio tra un atleta professionista e una persona qualunque – spariscono in altitudine. Gli autori concludono che non siano necessari alti livelli di V02max, come quello presenti in atlete e atleti professionisti, per scalare le vette più alte della Terra.
Il paper “A revision of maximal oxygen consumption and exercise capacity at altitude 70 years after the first climb of Mount Everest” di Giacomo Strapazzon, direttore dell’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna di Eurac Research, e Guido Ferretti, fisiologo dell’Università di Brescia, è stato pubblicato su The Journal of Physiology. È disponibile ad accesso libero qui.
La Silver Hut Expedition: non solo yeti, ma anche fisiologia d’altitudine
A quasi dieci anni dalla fortunata prima ascesa dell’Everest, Edmund Hillary e il dottor Griffith Pugh organizzarono un’ulteriore spedizione in Himalaya. Questa volta l’intento era principalmente scientifico: studiare la fisiologia dell’acclimatamento di un essere umano portato ad altitudini estreme per un periodo di tempo prolungato.
Collegate allo studio, c’erano anche altre sfide accessorie che probabilmente affascinarono di più la stampa dell’epoca. Medici e alpinisti ne approfittarono per cercare delle evidenze scientifiche dell’esistenza dello yeti, il leggendario uomo delle nevi parte della cultura locale. Si tentò anche l’ascesa del Makalu, la quinta vetta più alta della Terra, a 8470 m. s.l.m., che Edmund Hillary ipotizzò poter raggiungere senza ossigeno ausiliario.
La spedizione prese il nome di Himalayan Scientific and Mountaineering Expedition, ma divenne successivamente famosa come la Silver Hut Expedition. Era il 1960.
Dal punto di vista scientifico, la Silver Hut Expedition fu un successo. Alcune delle misurazioni effettuate rimasero ineguagliate per oltre 40 anni. Il team scelto da Griffith Pugh e Edmund Hillary era formato principalmente da fisiologi, alpinisti e specialisti vari – tra loro c’erano personaggi di spicco nel mondo della medicina di montagna come James (Jim) Milledge e l’americano John West . Griffith Pugh aveva una lunga lista di fenomeni da studiare, in particolare voleva capire l’effetto dell’altitudine sull’esercizio fisico in soggetti acclimatati e gli effetti che l’ipossia ha sul sistema di trasporto dell’ossigeno nell’organismo, dai polmoni fino ai tessuti umani.
Nel concreto, lo studio assomigliava a un avveniristico campo di battaglia: alcuni dei test si svolsero addirittura a 7740 m di quota. Per l’occasione fu usata una capanna prefabbricata da far giungere in quota insieme agli strumenti di misura necessari grazie agli yak, un trasporto straordinario tutt’altro che semplice. Un ergometro fu appositamente realizzato ad hoc, si poteva assemblare e disassemblare facilmente ed essere posizionato in spalla ai trasportatori. Vennero raccolti campioni di aria respirata, una macchina portatile realizzava degli ECG. Un apparecchio auricolare inventato dal fisiologo John West – anche lui membro della spedizione – fu usato per misurare la pressione dell’ossigeno. Un dettagliato paper di James Milledge descrive i quesiti scientifici che vennero affrontati.
La domanda a cui tutti volevano rispondere era: come si comporta il nostro organismo sotto sforzo ad altitudini estreme? Ancora oggi molte di queste domande rimangono senza una risposta certa.
Come si fa a scalare l’Everest senza bombole?
Torniamo però alla domanda fondamentale dell’alpinismo e della fisiologia d’altitudine nel secolo scorso: qual è il consumo massimo di ossigeno ad altitudini estreme? Ovvero: si può raggiungere la vetta dell’Everest senza ossigeno supplementare? Nel 1978, Reinhold Messner e Peter Habeler risposero a modo loro a questa domanda, rivoluzionando in un sol colpo l’alpinismo e la ricerca.
Come per ogni nuova scoperta, anche qui esiste un precursore. Il suo nome è Alexander Kellas, un chimico scozzese che già a inizio secolo aveva predetto che si sarebbe potuta raggiungere la cima dell’Everest senza ossigeno supplementare. “L'Everest può essere scalato da un uomo di eccellente costituzione fisica e mentale, in ottima forma, senza ausili avventizi,” scrisse, “a patto che le difficoltà fisiche imposte dalla montagna non siano troppo grandi". Il consumo di ossigeno misurato in vetta oggi è sorprendentemente vicino a quello previsto da Kellas. Sicuramente non giovò al successo della teoria di Kellas, il fatto che l’unico alpinista che provò a scalare l’Everest seguendo i suoi principi morì sfortunatamente nell’impresa. Il suo nome era George Mallory, uno dei più grandi alpinisti dell’epoca, che scomparve durante il tentativo di ascesa nel 1924. I primi a riprovare senza ossigeno furono Reinhold Messner e Peter Habeler.
A seguire dal punto di vista medico la spedizione del 1978 fu Oswald Oelz, un medico di Berna e fidato consigliere in fatto di fisiologia di Reinhold Messner. All’epoca si pensava ancora che gli alpinisti avessero straordinarie caratteristiche fisiologiche, al pari degli atleti d’élite. Le misurazioni effettuate da Oelz dimostrarono il contrario. Parametri come il massimo consumo di ossigeno, fibre muscolari e massima potenza anaerobica risultavano tutt’altro che eccezionali in alpinisti di successo, come Messner e Habeler.
Cosa gli aveva permesso allora di giungere in cima al mondo senza bombole?
AMREE e l’operazione Everest II
Per rispondere a questa domanda si organizzò un’ulteriore scalata nel 1981: la spedizione AMREE – acronimo per American Medical Research Expedition to Everest. L’idea di John West, il fisiologo australo-americano primo promotore dello studio, era quella di raggiungere la vetta dell’Everest nella cornice di una pura ricerca scientifica sul campo. L’Everest diventava una sorta di laboratorio, non solo il sogno di tanti alpinisti.
A raggiungere la cima furono due medici della spedizione. Uno di questi, Chris Pizzo, raccolse in vetta dei campioni di aria respirata per esaminare la composizione dell’aria alveolare – quella all’interno dei nostri polmoni – a 8.848 metri sul livello del mare. Un dato mai registrato prima ovviamente. Furono riportati a valle 4 campioni di aria raccolti in cima e altri 30 a diverse altitudini. Il secondo medico ad arrivare in cima fu Peter Hackett, uno dei pionieri della medicina d’alta quota e oggi membro del comitato scientifico dell’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna, in Eurac Research.
Per la prima volta fu misurata anche la pressione barometrica in vetta, sostituendo finalmente le proiezioni con un dato reale. Altre misurazioni furono effettuate sul consumo massimo di ossigeno in quota. Da AMREE nacque un’ulteriore, pionieristica idea: riportare gli alpinisti in una camera ipobarica dove simulare l’altitudine dell’Everest e compiere quante più misurazioni possibile a diverse altitudini. L’obiettivo era indagare in ambiente controllato la risposta del sistema respiratorio all'esposizione all'ipossia sia a riposo che durante l'esercizio fisico in diverse fasi di acclimatazione all'altitudine. Lo studio prese il nome di Operation Everest II.
Il tutto avvenne nell’ottobre del 1985 a Natick, nel Massachusetts, dove 8 soggetti e 27 membri di un comitato di ricerca – sotto la guida di Charles Houston, che aveva curato la Operation Everest del 1946 – si incontrarono nelle camere ipobariche dell'United States Army Research Institute for Environmental Medicine (USARIEM) per studiare le risposte del corpo umano a una scalata simulata di 40 giorni del monte Everest. Ancora oggi lo studio rimane un esempio quasi ineguagliato di cooperazione tra ricerca di campi diversi.
Parametri fisiologici, desiderio e motivazione degli “individui eccezionali”
Siamo a metà degli anni Ottanta e per la prima volta qualche dato ci conferma che effettivamente l’impresa di Messner e Habeler avvenuta quasi un decennio prima fosse in qualche modo realizzabile anche dal punto di vista fisiologico. Il valore VO2max misurato all’interno dello studio AMREE suggerisce ad esempio che individui eccezionali possono effettivamente scalare l’Everest senza bombole. Tutti concordano però sul fatto che, al di là dei parametri fisiologici, ci deve essere anche altro: quali sono questi individui eccezionali?
Nel 1986, un paper del medico Oswald Oelz trae queste conclusioni: “Le caratteristiche principali di un alpinista di successo sono, oltre a un equilibrio funzionale ottimale e a un'abilità fuori dal comune, una forte motivazione e uno slancio eccezionale. Reinhold Messner, il primo alpinista a superare la barriera degli 8500 m senza ossigeno supplementare, è stato il simbolo di questi scalatori. Era caratterizzato da caratteristiche fisiologiche piuttosto normali, ma dalla necessità ossessiva di essere il primo e il migliore, con "mezzi leali", come lui stesso afferma, cioè senza l'ausilio dell'ossigeno in qualsiasi fase dell'ascesa".
Motivazione, desiderio e strategia: nello studio del corpo di chi pratica l’alpinismo non si può prescindere dal tenere in conto anche questi elementi. Nel frattempo, negli anni Novanta, studi fisiologici ridimensionano l’importanza del parametro VO2max. Più si sale in quota, più le differenze di questo valore riscontrate negli individui si assottigliano. Conclusione: non c’è bisogno di valori estremamente buoni di VO2max al livello del mare, come quelli di atleti e atlete d’élite, per poter scalare l’Everest senza bombole. Messner e Habeler lo avevano dimostrato empiricamente venti anni prima.
Nel nuovo millennio gli studi scientifici non si sono certo fermati. Nel 2007, ad esempio, nella cornice della Caudwell Xtreme Everest Expedition sono stati prelevati dei campioni di sangue arterioso quasi alla quota dell’Everest che mostravano livelli di saturazione incompatibili con la vita, in soggetti non acclimatati.
Anche se qualcuno ancora cerca il test scientifico perfetto in grado di anticipare i risultati di un’impresa mai tentata prima, oggi è chiaro che non ci sono fattori fisiologici completamente predittivi che ci possano confermare se una spedizione avrà successo o meno, e in che modo. L’alpinismo non è solo fisiologia.
E le alpiniste? Uno studio medico di Eurac Research accompagna la spedizione femminile sul K2 promossa dal CAI per i 70 anni dalla prima ascesa italiana
Otto donne, quattro italiane e quattro pakistane, partiranno a giugno per il Pakistan per tentare di scalare la seconda vetta più alta del mondo, nonché una tra le più difficili. Ripercorreranno i passi della spedizione italiana che nel 1954 portò la Lacedelli e Compagnoni in cima al K2. È proprio per celebrare questo anniversario che il Club Alpino Italiano ha promosso questa impresa, con la stessa meta ma con uno spirito diverso: sarà un’opportunità di formazione, ricerca e promozione di valori culturali e sociali.
Il fatto che le protagoniste siano otto donne rende la spedizione un’opportunità unica per la ricerca: un’équipe medica insieme a ricercatori e ricercatrici di Eurac Research affiancheranno la spedizione per studiare la fisiologia femminile a quote estreme, un ambito su cui la comunità scientifica dispone ancora di conoscenze limitate.
Eurac Research ha promosso questo studio con l’obiettivo di studiare le risposte fisiologiche di alpiniste allenate prima e dopo una scalata reale, e poi durante una riesposizione a un'altitudine simulata - che potrà andare fino a 8848 metri – nella camera ipobarica di terraXcube a Bolzano. Il gruppo di ricerca si concentrerà anche sul processo di perdita dell’acclimatamento (de-acclimatamento).
Si tratta di un protocollo innovativo che permetterà di osservare fenomeni fisiologici mai osservati prima nelle donne. Gli aspetti che lo rendono unico sono il focus sulla fisiologia femminile, la riesposizione a quote estreme in terraXcube di sportive acclimatate dopo la scalata e la possibilità di osservare il de-acclimatamento dopo un’ascesa reale e dopo la riesposizione all'altitudine estrema.