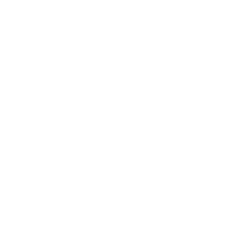magazine_ Interview
Come si cambia dopo un incidente in montagna
Uno studio dimostra che le persone a volte sviluppano disturbi psicologici da stress, ma possono anche uscire più forti dall’incidente
Un incidente in montagna, anche se si conclude senza conseguenze gravi, può talvolta avere effetti a lungo termine. Il 20 per cento delle pazienti e dei pazienti ospedalizzati che sono stati intervistati soffre infatti di sintomi di disturbo da stress post-traumatico ancora sei mesi dopo un incidente in montagna. Per il medico d’emergenza Hermann Brugger, che in studi precedenti aveva già analizzato i disturbi post-traumatici nelle vittime di valanghe, un risultato particolarmente interessante è che un terzo delle persone intervistate sia uscito rafforzato da un’esperienza così negativa.
Cosa si intende esattamente per disturbo da stress post-traumatico?
Hermann Brugger: I sintomi principali sono i ricordi ossessivi; le persone in questo caso si ricordano dell’incidente subito in tutte le occasioni. E il ricordo ha connotazioni negative. Si tratta dei cosiddetti flashback, che possono essere acustici o visivi. Ad esempio, è frequente che le vittime di valanghe percependo un semplice rumore forte pensino subito all’imminenza di una valanga. Questi ricordi ossessivi non sono necessariamente pericolosi, ma sono estremamente fastidiosi e hanno un impatto decisamente negativo sulla qualità della vita. Anche i sogni sono frequenti, così come la tendenza ad evitare alcune situazioni: si evitano azioni o attività che possono provocare questi flashback; per esempio, ci sono persone che non si mettono più alla guida dopo aver vissuto o assistito a incidenti stradali perché vogliono evitare particolari ricordi.
È sorprendente allora che la maggior parte delle persone intervistate, dopo un incidente, sia tornata a vivere le stesse attività in montagna e che in alcuni casi sia addirittura uscita dall’incidente più forte di prima…
Brugger: L’aspetto nuovo e sorprendente per me è che il gruppo di persone che dopo un incidente sono ancora più resistenti psicologicamente rispetto a prima ha le stesse dimensioni del gruppo di persone che hanno sviluppato il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Vi illustro brevemente lo studio, che è stato realizzato sotto la direzione di Katharina Hüfner dell’Università medica di Innsbruck: Sono state intervistate 307 persone ricoverate in ospedale dopo un incidente in montagna. Si trattava principalmente di incidenti di sci e ciclismo. L’indagine è stata condotta online utilizzando diversi test psicologici che riguardano specificamente il PTSD, ma anche la resilienza, la qualità della vita, i sintomi di ansia e la depressione. Questi aspetti non erano mai stati analizzati in modo così dettagliato prima d’ora. Sono state ad esempio eseguite diverse serie di test psicologici, le cosiddette “batterie”. Dai dati, utilizzando il metodo statistico del clustering, abbiamo quindi identificato tre diversi gruppi: il gruppo di coloro che hanno sviluppato sintomi di PTSD; il gruppo dei neutrali per i quali non è cambiato nulla dopo l’incidente; e il gruppo con “crescita post-traumatica”, cioè coloro che sono stati in grado di trarre forza positiva dalla brutta esperienza e di emergere psicologicamente più forti. Tutti e tre i gruppi erano più o meno equamente distribuiti nel nostro campione. Anche se non è rappresentativa, questa distribuzione è molto interessante. Si dice comunemente che “ciò che non ti uccide ti rende più forte”. È una citazione di Friedrich Nietzsche ed è vera in questo caso.
Invece un terzo delle persone intervistate ha sviluppato i sintomi di un disturbo mentale da stress dopo l’incidente in montagna.
Brugger: Sì, lo studio apre un nuovo scenario di ricerca sul post-trauma, ma dimostra anche quanto sia importante riconoscere precocemente i sintomi del PTSD e fornire sostegno alle persone colpite. In questo contesto, abbiamo visto nel questionario che circa il dieci per cento delle persone affette da PTSD ha ricevuto assistenza psicologica. Un ulteriore sette per cento avrebbe ritenuto necessaria tale assistenza, ma non ha ricevuto alcun aiuto. Questo vuol dire che c’è ancora molto da fare. La prevenzione è importante per evitare i disturbi da stress o per ridurne al minimo le conseguenze. Non dobbiamo dimenticare che l’alpinismo ha un importante effetto di promozione della salute: andare in montagna rende sani. La popolazione altoatesina è tra le migliori in Europa per quanto riguarda l’aspettativa di vita, e questo si può certamente attribuire all’attività fisica. Le persone vanno regolarmente in montagna, in bicicletta e così via. Insieme all’assistenza medica, questo ha impatto sulla salute. Sappiamo anche che le persone che praticano regolarmente sport di montagna hanno un livello di resilienza più elevato, il che significa che sono in grado di affrontare meglio le esperienze negative. Sono quindi intrinsecamente più protetti dai sintomi del PTSD. È chiaro che andare in bicicletta in montagna, sciare o fare alpinismo sono attività associata a un certo rischio di incidenti. Ma sappiamo anche che l’alpinismo e l’altitudine hanno un effetto molto positivo sulla salute mentale delle persone. Ecco perché bisogna sempre guardare al quadro generale.
Lo studio „Three distinct patterns of mental health response following accidents in mountain sports: a follow‑up study of individuals treated at a tertiary trauma center”
Il team di ricerca ha invitato pazienti maggiorenni di lingua tedesca a partecipare a un sondaggio online alcuni mesi dopo essere stati curati a causa di un incidente in montagna presso la Clinica universitaria di ortopedia e traumatologia di Innsbruck. Il totale di 307 partecipanti aveva subito lesioni minori (37 per cento), moderate (35 per cento) e gravi (28 per cento). La maggior parte di questi incidenti si è verificata durante lo sci o lo snowboard su piste sicure (poco meno del 60 per cento), seguiti da ciclismo ed escursionismo. L’obiettivo dell’indagine era scoprire come le vittime degli incidenti avessero affrontato psicologicamente l’evento.
Il risultato dello studio: i pazienti e le pazienti sono stati assegnati a tre gruppi di modelli di reazione psicologica. Un terzo delle persone non mostrava sintomi di PTSD ed era mentalmente sano. Un altro terzo, mediamente di età più giovane, mostrava sintomi che potevano indicare PTSD e allo stesso tempo sintomi di depressione, panico e ansia. La caratteristica dell’ultimo terzo di persone è stata la cosiddetta crescita post-traumatica, cioè una maggiore resilienza, grazie alla quale sono uscite più forti dall’incidente.
Link allo studio pubblicato sulla rivista European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience: https://doi.org/10.1007/s00406-024-01807-x
Hermann Brugger
Il medico di emergenza Hermann Brugger ha fondato l’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna di Eurac Research e lo ha diretto dal 2009 al 2022. Brugger aveva già studiato l’insorgenza del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) nelle vittime di valanghe alcuni anni fa e ha supportato il gruppo di ricerca di Innsbruck guidato da Katharina Hüfner nella progettazione del questionario dello studio.