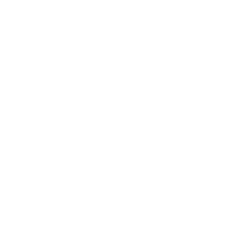magazine_ Interview
Lacune pericolose
Che cos’è il gender data gap e perché dovremmo occuparcene
Nella nostra società le disparità tra uomini e donne sono ancora molte. Si va dalla disuguaglianza retributiva a quella delle pensioni e nella distribuzione del lavoro di cura, giusto per citarne alcune. C’è però una forma di disuguaglianza che è particolarmente insidiosa: è il gender data gap, la carenza di dati scientifici sulle donne in campo medico. Ne parliamo con Katharina Crepaz, ricercatrice presso il Center for Autonomy Experience di Eurac Research ed esperta di Gender Dynamics, e Giacomo Strapazzon, medico e direttore del nostro Istituto per la medicina di emergenza.
Diversi studi dimostrano che i soggetti femminili sono sottorappresentati nelle ricerche mediche. Come si spiega questo fenomeno?
Katharina Crepaz: Nella medicina esiste il "paziente normale": giovane, maschio, bianco, senza disabilità, alto 1,80 metri e con un peso di 80 chili. Chiunque si discosti da questa presunta norma, come donne e minoranze, è sottorappresentato. Le donne, in particolare, sono considerate soggetti di studio "difficili" per due motivi: in primo luogo per il ciclo mestruale, che implica fluttuazioni ormonali che devono essere prese in considerazione negli studi, e in secondo luogo per la possibilità di gravidanza. I test farmacologici, infatti, potrebbero avere effetti sul feto.
Giacomo Strapazzon: Effettivamente il soggetto di sesso femminile è più complesso da studiare per via delle fluttuazioni ormonali legate al ciclo mestruale. Quando si vuole condurre lo studio su un campione fisiologicamente omogeneo, è molto più semplice farlo con soggetti di sesso maschile. Per standardizzare la condizione fisiologica delle partecipanti occorrerebbe inibire il ciclo mestruale, ma così si perderebbero informazioni potenzialmente interessanti.
Nella medicina esiste il "paziente normale". Chiunque si discosti da questa presunta norma, come donne e minoranze, è sottorappresentato.
Katharina Crepaz
Ma davvero la complessità della fisiologia femminile è un buon motivo per non includere le donne nelle ricerche?
Katharina Crepaz: Si tratta di una scusa dietro cui si celano le reali motivazioni, che sono economiche. Certo, condurre studi sulle donne è più lungo e costoso se si deve tener conto di fattori come le fluttuazioni del ciclo, ma questo non è un motivo valido per escludere i soggetti femminili dalle ricerche. La politica sanitaria deve garantire un'assistenza adeguata a tutti i gruppi di popolazione, indipendentemente dai fattori economici, e quindi devono essere attuate linee guida adeguate anche per la ricerca medica.
Giacomo Strapazzon: Confermo la necessità di dover fare economia di risorse. Comunque, l’inclusione di uno o di entrambi i sessi dipende anche dalla domanda di ricerca che ci si sta ponendo. In alcuni casi può avere senso studiarne soltanto uno. A volte, per esempio quando non ci si aspetta di trovare differenze tra i due sessi, si può scegliere di condurre uno studio preliminare sui soggetti più facili da studiare, ovvero quelli maschili, per poi, in caso si abbiano risultati interessanti, approfondire le ricerche includendo anche quelli femminili. In altri casi, invece, includere i soggetti femminili nello studio è imprescindibile, come quando si stanno testando cure destinate alle donne.
L’inclusione di uno o di entrambi i sessi dipende anche dalla domanda di ricerca che ci si sta ponendo.
Giacomo Strapazzon
Signora Crepaz, nei suoi studi, si è occupata dei determinanti sociali della salute. Abbiamo detto che la componente ormonale rende complesso lo studio della fisiologia femminile. Ma ci sono altri fattori che influiscono negativamente sulle opportunità delle donne di essere incluse negli studi clinici ed eventualmente godere di buona salute?
Katharina Crepaz: Gli ormoni, così come l’età e i fattori ereditari, sono tra i determinanti biologici della salute di una persona. Ci sono poi dei fattori sociali che giocano un ruolo altrettanto importante nella possibilità di accesso a cure appropriate. Tra questi ultimi ci sono, per esempio, i pregiudizi degli operatori sanitari. Gli studi dimostrano che il dolore delle donne è classificato come meno grave di quello degli uomini e che, spesso, i loro disturbi fisici sono erroneamente diagnosticati come psicologici.
Perché è importante includere le donne negli studi clinici, così come analizzarne i risultati disaggregandoli per sesso? E quali sono i rischi che comporta la mancata inclusione delle donne nelle ricerche in materia di salute?
Giacomo Strapazzon: Escludere a priori le donne ci costringe ad assumere che i risultati ottenuti da ricerche condotte su soli uomini vadano bene anche per i soggetti femminili. Questo, però, non è sempre vero, anche per via di quelle differenze ormonali a cui abbiamo già accennato. Nelle donne, ad esempio, il rischio cardiovascolare aumenta significativamente dopo la menopausa. Per conoscere il ruolo giocato dal genere biologico sull’insorgenza di determinate malattie e mettere a punto linee guida per prevenirle e cure per contrastarle bisogna quindi studiare soggetti di entrambi i sessi. Più in generale, possiamo dire che per valutare l’efficacia di una cura, questa andrebbe testata nella popolazione alla quale è destinata.
Katharina Crepaz: Aggiungo che le donne rappresentano la metà della popolazione mondiale. Escludere dagli studi una fetta così ampia della popolazione sarebbe irresponsabile e significherebbe non avere una base scientificamente valida per le terapie. Sappiamo che spesso i farmaci funzionano in modo diverso nelle donne e che il dosaggio deve essere adattato alla differente fisiologia dei due sessi. Condurre gli studi solo sul "paziente normale", ovvero quello di sesso maschile, potrebbe quindi avere conseguenze fatali per la salute femminile. Spesso, inoltre, le donne presentano sintomi diversi da quelli degli uomini. Come nel caso dell'infarto: grazie alle campagne di sensibilizzazione, la maggior parte della popolazione sa che il dolore al lato sinistro del petto che si irradia al braccio è un segnale di allarme. Tuttavia, le donne avvertono altri sintomi, come un forte dolore tra le scapole. Questi segnali non vengono associati a un attacco cardiaco o vengono riconosciuti troppo tardi.
Escludere a priori le donne ci costringe ad assumere che i risultati ottenuti da ricerche condotte su soli uomini vadano bene anche per i soggetti femminili.
Giacomo Strapazzon
Nel suo libro “Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano.”, Caroline Criado Perez afferma che, secondo alcuni scienziati, reclutare partecipanti donne sia difficile. Come rispondere a chi sostiene questa tesi?
Katharina Crepaz: Esistono diversi gruppi di popolazione relativamente difficili da raggiungere: quando si tratta di partecipare agli studi, sono le donne e le persone con background migratorio, mentre, quando si tratta di partecipare alle misure di prevenzione, sono gli uomini. Tuttavia, questo fatto non deve essere usato come giustificazione per escludere alcuni gruppi dalla ricerca e dall’assistenza medica. Quello che andrebbe fatto è creare programmi specifici per ognuno di essi.
Giacomo Strapazzon: Io non direi che le donne siano a prescindere soggetti più difficili da raggiungere. Possono esserlo quando entrano in gioco certe barriere culturali, come nel caso delle donne di fede musulmana. In tal caso, condurre alcuni test può risultare complicato in quanto costringerebbero le partecipanti a spingersi ben aldilà della loro zona di comfort.
Istituzioni pubbliche di vari Paesi, come i National Institutes of Health negli Stati Uniti, hanno emanato delle norme che impongono l’inclusione di soggetti femminili nei test clinici. Disposizioni simili sono fornite da associazioni come la Società tedesca di epidemiologia, che obbliga le sue ricercatrici e i suoi ricercatori a giustificare l’inclusione di soggetti di un solo sesso negli studi che potrebbero interessarli entrambi. Qual è la situazione in Italia?
Giacomo Strapazzon: Anche in Italia si va nella stessa direzione di altri Paesi. Gli stessi comitati etici che devono approvare i progetti di ricerca promuovono l’inclusione di entrambi i sessi.
Katharina Crepaz: Inoltre, nel 2022, l'Unione Europea ha introdotto delle norme che rendono obbligatoria una distribuzione rappresentativa del genere e dei gruppi di età nelle sperimentazioni cliniche. In Italia, in particolare, nel 2023, l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato delle linee guida per una ricerca medica equa dal punto di vista sia del genere biologico, ovvero del sesso dell’individuo, sia del genere sociale. Un passo importante nella giusta direzione.
Nel 2022, l'Unione Europea ha introdotto delle norme che rendono obbligatoria una distribuzione rappresentativa del genere e dei gruppi di età nelle sperimentazioni cliniche.
Katharina Crepaz
Concludiamo questa intervista affrontando un tema più specifico. Come riporta una recente pubblicazione scientifica, nonostante le donne scalino le montagne sin dall’avvento del moderno alpinismo, la maggior parte degli studi sulla fisiologia umana in alta quota sono stati condotti su soggetti maschi. Come mai?
Katharina Crepaz: Credo che questo abbia sempre a che fare con la complessità degli studi che tengono conto del ciclo femminile. Inoltre, l'argomento del ciclo mestruale e delle mestruazioni è ancora un tabù; ancora oggi, fa notizia che le atlete parlino di come le mestruazioni influenzano le loro prestazioni – cosa che, almeno, accade sempre più spesso. Inoltre, fortunatamente, nella scienza dello sport è sempre più comune lavorare consapevolmente con il ciclo mestruale, attraverso allenamenti preparati tenendone conto. Spero che questi approcci portino il tabù del ciclo femminile sotto i riflettori della società.
Giacomo Strapazzon: C’è anche da dire che, per lungo tempo, l’alpinismo è stato praticato per lo più da uomini. In uno studio che abbiamo condotto simulando dei seppellimenti da valanga, la maggior parte del campione era composto da soggetti di sesso maschile. Questo perché avevamo reclutato i partecipanti tra scialpinisti, membri del soccorso alpino, del soccorso piste e guide alpine, tutte attività tuttora praticate più spesso dagli uomini che dalle donne. Lo scenario, comunque, sta cambiando.
L'argomento del ciclo mestruale e delle mestruazioni è ancora un tabù; ancora oggi, fa notizia che le atlete parlino di come le mestruazioni influenzano le loro prestazioni.
Katharina Crepaz
A tal proposito, l’Istituto per la medicina di emergenza di Eurac Research ha avviato un progetto che mira a studiare la fisiologia femminile ad alta quota. Signor Strapazzon, ce ne parla un po’?
Giacomo Strapazzon: A settant’anni dalla conquista del K2, il Club Alpino Italiano ha promosso un’iniziativa che vede otto alpiniste impegnate nella scalata di questa vetta. Qui all’Istituto per la medicina di emergenza studieremo la fisiologia delle alpiniste, prima e dopo la spedizione. Lo scorso marzo, le otto scalatrici hanno svolto i test preliminari presso il terraXcube, il simulatore di ambienti estremi di Eurac Research. Durante questi test sono state valutate la funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria e cerebrale delle partecipanti, le quali ripeteranno le analisi ad agosto, una volta conclusasi la loro avventura. L’obiettivo è accumulare dati sui processi fisiologici che sottendono l’acclimatamento femminile a quote estreme.
Quali ricadute potrebbe avere questo studio sulla vita di chi non vive ad alta quota e non scala le montagne?
Giacomo Strapazzon: In alta quota, la quantità di ossigeno in grado di raggiungere i tessuti corporei diminuisce. Si tratta di una condizione che prende il nome di “ipossia” e che può accomunare chi pratica alpinismo a quote elevate e chi soffre di particolari condizioni patologiche. Indagare la risposta del corpo alla carenza di ossigeno può, quindi, tornare utile nella cura dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e sub-intensiva.
Katharina Crepaz
Katharina Crepaz è senior researcher presso il Center for Autonomy Experience di Eurac Research. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze politiche presso l'Università di Innsbruck e l'abilitazione scientifica in Scienze della salute presso l'Università Tecnica di Monaco di Baviera.
Giacomo Strapazzon
Giacomo Strapazzon è direttore dell’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna di Eurac Research nonché medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Ha conseguito un dottorato in Biomedicina all’Università di Padova e insegna alla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza e Medicina dello Sport.