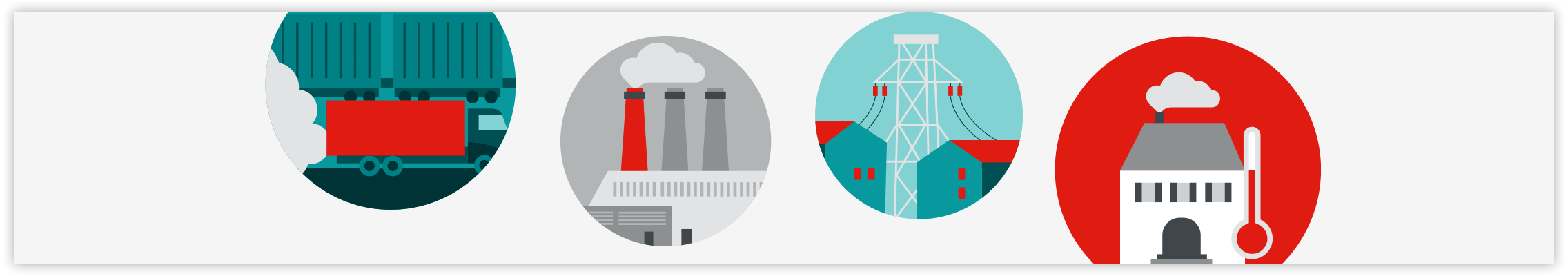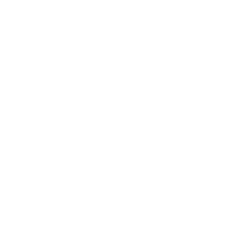magazine_ Interview
“Il 70% teme le conseguenze negative del cambiamento climatico.”
Per la prima volta uno studio analizza il fenomeno dell’eco-ansia in Alto Adige. Felix Windegger e Christoph Kircher presentano i risultati
Quali emozioni positive e negative vengono associate alla crisi climatica, ai suoi effetti, ai provvedimenti e alle strategie adottate per contrastarla? È possibile individuare una sorta di eco-ansia anche in Alto Adige? E quali sono le differenze tra i diversi gruppi sociali? Eurac Research e l’Istituto provinciale di statistica ASTAT hanno rilevato con quali stati d’animo le persone in Alto Adige reagiscono al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. Gli autori dello studio sono il socio-economista Felix Windegger e il sociologo Christoph Kircher.
Perché è importante tramite la ricerca analizzare come le persone si sentono in relazione alla crisi climatica?
Felix Windegger: Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel contesto della crisi climatica perché gli effetti sono sempre più tangibili. A livello globale e anche in Alto Adige. Non tra dieci anni, ma qui e ora. Al contempo, diventa sempre più difficile raggiungere gli obiettivi climatici. Le persone vedono con i propri occhi che il cambiamento climatico è in atto e, di conseguenza, emergono reazioni emotive. Bisogna quindi chiedersi come questo influenzi le persone e come esse affrontino la situazione.
Christoph Kircher: Abbiamo esaminato molte indagini esistenti sul cambiamento climatico e abbiamo riscontrato che spesso includono domande molto astratte e tecniche, come quelle sulla riduzione di CO2 o su possibili sviluppi futuri. Tuttavia, tra le persone intervistate sono poche quelle che possiedono conoscenze approfondite su questi argomenti. Di solito ci si limita a ripetere quanto appreso dai media o da altre fonti. Nella nostra ricerca partiamo dal presupposto che conoscere e agire siano due dimensioni distinte. Sebbene si parli molto della necessità di rallentare il cambiamento climatico, nella pratica si fa ancora troppo poco. Ciò che realmente influenza il nostro agire è sempre legato anche alle emozioni: siamo emotivi nel percepire quello che ci circonda, grande o piccolo che sia, e reagiamo con stati d’animo differenti. Per questo motivo, abbiamo deciso di condurre uno studio più approfondito proprio su questo tema.
Poche persone sono soddisfatte degli sforzi attuali per la protezione del clima; predomina una sensazione di impotenza
"È fondamentale considerare fin dall’inizio, quando si vanno ad attuare misure concrete, meccanismi di compensazione sociale ed economica."
Felix Windegger
Come viene percepita la crisi climatica dalle altoatesine e dagli altoatesini?
Windegger: I risultati mostrano forti reazioni emotive con una netta prevalenza di sentimenti negativi. Questi vanno dalla preoccupazione per gli effetti diretti già tangibili, alla paura per le conseguenze future, fino alla frustrazione e all’impotenza di fronte agli sforzi attuali per mitigare la crisi climatica. Solo il 28 per cento delle persone è soddisfatto degli sforzi attuali. L’80 per cento delle persone intervistate dichiara di guardare con preoccupazione al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. Gli eventi meteorologici estremi, come siccità e carenza di risorse idriche, ma anche forti precipitazioni e alluvioni, sono considerati particolarmente preoccupanti. Il 70 per cento teme le conseguenze negative del cambiamento climatico e quasi il 40 per cento delle altoatesine e degli altoatesini si sente in colpa, perché ha la sensazione di poter o dover fare di più per la protezione del clima. Paura e senso di colpa sono emozioni molto discusse anche a livello internazionale. Questi sentimenti portano a notevoli carichi emotivi, che insieme agli impatti fisici e diretti del cambiamento climatico, probabilmente giocheranno un ruolo significativo anche in futuro. Iniziative come “Psychologists for Future” e “Psychotherapists for Future” si occupano ormai specificamente di questi aspetti.
Siccità e scarsità d’acqua così come piogge intense e alluvioni sono le preoccupazioni più grandi
"Nel nostro studio abbiamo riscontrato che il cambiamento climatico è percepito in modo molto diverso dai vari gruppi sociali."
Christoph Kircher
Ma i sentimenti negativi possono anche motivare le persone ad adottare più rapidamente misure concrete, non è vero?
Windegger: Sì, esistono effettivamente studi sulle emozioni e sul cambiamento climatico che lo confermano. In particolare, emozioni negative come la rabbia o il risentimento possono tradursi in un maggiore impegno politico o in cambiamenti nello stile di vita nell’ambito privato. La situazione diventa più complessa quando entra in gioco il senso di impotenza e le persone, sentendo di non poter più fare nulla per cambiare le cose, gettano la spugna.
Kircher: I dati mostrano che ci sono due modi principali di affrontare queste sensazioni. Da un lato, ci sono persone che reagiscono con la frustrazione. Dall’altro, ci sono coloro che, nonostante una grande preoccupazione e un serio impegno sul tema, guardano al futuro con ottimismo e ripongono grandi speranze nelle innovazioni tecnologiche e nelle soluzioni politiche per affrontare la crisi climatica. Nel nostro studio abbiamo riscontrato che il cambiamento climatico è percepito in modo molto diverso dai vari gruppi sociali. Per tracciare un quadro più differenziato degli stati d’animo delle altoatesine e degli altoatesini rispetto alla crisi climatica, abbiamo suddiviso le persone intervistate in tre gruppi caratterizzati da atteggiamenti simili: l’idealtipo preoccupato, diffidente e tranquillo.
Quali differenze avete notato tra i diversi gruppi?
Kircher: Nel gruppo delle preoccupate e dei preoccupati – il 39 per cento delle persone intervistate – la preoccupazione e la paura sono particolarmente intense. In relazione alle misure adottate finora per contenere il cambiamento climatico, queste persone hanno dichiarato di sentirsi particolarmente arrabbiate, frustrate e impotenti. Le tranquille e i tranquilli – il 36 per cento – sono soddisfatti degli sforzi compiuti e hanno grande fiducia nella capacità di superare bene la crisi climatica. La loro fiducia si basa soprattutto su soluzioni tecnologiche. Il 25 per cento delle persone intervistate appartiene alle diffidenti e ai diffidenti. Sebbene non neghino il cambiamento climatico, lo considerano un problema secondario. Questo gruppo respinge con veemenza regole e appelli per un comportamento più consapevole da un punto di vista climatico. Le proteste per il clima vengono classificate con maggior frequenza come inappropriate ed esagerate. Abbiamo riscontrato interessanti differenze in base al genere e al livello di istruzione, ma anche rispetto alle opinioni su politica economica e sullo stato della democrazia. Tra le preoccupate e i preoccupati si trovano più donne. Gli uomini e le persone con un diploma di scuola media o professionale vengono classificati più frequentemente tra le diffidenti e i diffidenti.
Le conseguenze negative del cambiamento climatico non colpiscono tutte le persone allo stesso modo
Nel corso della vostra valutazione ci sono stati risultati che vi hanno particolarmente sorpreso?
Windegger: Ciò che è davvero interessante e sicuramente unico in Alto Adige sono le differenze emerse tra i vari gruppi linguistici. Le persone di madrelingua italiana appartengono più frequentemente all’idealtipo tranquillo, mentre le persone di madrelingua tedesca appartengono più spesso all’idealtipo diffidente e preoccupato.
Kircher: Riteniamo che ciò sia dovuto al dibattito sul cambiamento climatico nei paesi di lingua tedesca, che viene condotto in modo più intenso. La madrelingua e la relativa esposizione mediatica sono, a nostro avviso, i fattori determinanti per reazioni emotive diverse, più del luogo di residenza o di altre caratteristiche sociodemografiche.
Windegger: Abbiamo riscontrato anche delle differenze rispetto allo studio del 2022. Alla domanda sulle tre sfide più importanti, il cambiamento climatico è ancora al primo posto in classifica. Tuttavia, abbiamo registrato un aumento significativo di 12 e 10 punti percentuali per i temi della migrazione e della sicurezza pubblica rispetto al 2022. Questo indica che nel 2023 altri problemi sono diventati prioritari, probabilmente anche a causa delle tematiche dibattute prima delle elezioni provinciali.
Cosa significano concretamente questi risultati per l’Alto Adige?
Windegger: I risultati dell’indagine dimostrano chiaramente che non si tratta più di stabilire se il cambiamento climatico esista a priori o se sia causato dall’uomo. Ora bisogna capire come affrontarlo a livello sociale e politico – e su questo punto le posizioni dei tre gruppi spesso divergono notevolmente.
Kircher: Le tranquille e i tranquilli come pure le preoccupate e i preoccupati sono disposti a modificare il proprio stile di vita e ad accogliere positivamente gli appelli ad agire in modo sostenibile. Mentre le diffidenti e i diffidenti mostrano un forte risentimento verso chi è favorevole a cambiare comportamento e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Questa posizione è accompagnata da emozioni molto negative. Alcune persone si discostano e diventano insensibili anche a politiche pragmatiche, poiché le associano a un’agenda con cui non vogliono essere identificate. Chi attua politiche in materia deve tenere conto delle grandi tensioni esistenti tra i vari gruppi della popolazione.
"Come vogliamo vivere in quanto società civile è una questione politica che dovrebbe essere trattata all'interno della società e non della scienza."
Felix Windegger
Nello studio emerge che addirittura il 56 per cento dubita che ci possa essere una soluzione democratica alla crisi climatica. Come va interpretato questo risultato?
Kircher: Sì, addirittura il 56 per cento ha dichiarato di essere favorevole alla sospensione temporanea di principi democratici (almeno in casi eccezionali) per accelerare i processi che portano a mitigare il cambiamento climatico, mentre solo un terzo è assolutamente contrario. Questi risultati dimostrano che la popolazione ha poca fiducia che i policy maker contrastino in maniera tempestiva e consapevole i rapidi cambiamenti causati dal cambiamento climatico. Ciò potrebbe anche essere legato al fatto che, sebbene le persone si rendano conto che gli avvertimenti aumentano, quando si tratta di mettere in atto misure concrete, i policy maker fanno marcia indietro. Inoltre, abbiamo notato che il grado di soddisfazione per le politiche in materia di clima è significatamene correlato alla soddisfazione generale verso la democrazia.
Windegger: Un’altra spiegazione apparentemente paradossale per questo risultato potrebbe essere la mancanza di opportunità di partecipazione. Le cittadine e i cittadini vengono a malapena coinvolti nei processi decisionali. Se le discussioni si tengono a porte chiuse e poi non segue un agire concreto, nasce l’impressione che il sistema non sia adatto a reagire con rapidità. Alcune persone mettono in discussione la legittimità della democrazia nelle questioni climatiche, a causa della sua lentezza, dell’influenza delle lobby e dei processi decisionali rallentati. Tuttavia, è importante sottolineare chiaramente che le idee “eco-autoritarie” proposte da alcuni sono problematiche sotto molti aspetti e non garantiscono affatto una maggiore protezione del clima (i dati empirici suggeriscono appunto il contrario). E poi ci sono coloro che sostengono che qualsiasi intervento politico sul clima sia autoritario e quindi da respingere.
La giustizia sociale dovrebbe essere considerata maggiormente in questioni climatiche
Tuttavia, esistono anche altri divieti e regolamenti, come l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza mentre si guida. Perché le persone reagiscono con tale intensità proprio a questioni relative alla politica climatica?
Kircher: È davvero un tema con fortissime connotazioni emotive. Il fatto che le politiche in materia di clima e le questioni di democrazia siano spesso discusse insieme è dovuto anche al fatto che il cambiamento climatico è stato definito principalmente dalla scienza. Le scienziate e gli scienziati lo rendono visibile attraverso scenari e modelli, ma per molti rimane difficile da comprendere e non direttamente riferibile alla sfera personale. Sebbene la consapevolezza del cambiamento climatico e delle sue conseguenze sia ormai diffusa nella società, le proposte di soluzione continuano a provenire dal mondo della scienza. In parole semplici, la percezione è spesso questa: la scienza definisce il problema e offre soluzioni, mentre la politica sembra troppo inefficiente per attuarle. Di conseguenza, le persone possono essere portate a pensare che sia meglio seguire direttamente le esperte e gli esperti nelle questioni importanti, escludendo la politica. Ma questa argomentazione segue una logica postpolitica molto problematica. La scienza può raccomandare di ridurre le emissioni di CO2, ma è compito della politica rendere le misure socialmente eque e implementarle.
Windegger: Come vogliamo vivere in quanto società civile è una questione politica che dovrebbe essere trattata all'interno della società e non della scienza.
Le emozioni che suscita il clima: tre gruppi sociali
Nel vostro studio avete analizzato anche la percezione della responsabilità e giustizia sociale rispetto alla politica climatica. Come si pongono le altoatesine e gli altoatesini rispetto a questi temi?
Windegger: Abbiamo effettivamente riscontrato una grande sensibilità per le questioni di giustizia. Il 60 per cento ritiene che le persone saranno colpite in modo diseguale dalle conseguenze del cambiamento climatico, citando come fattori principali il luogo di residenza e aspetti socioeconomici. Per il 65 per cento la giustizia sociale dovrebbe essere maggiormente considerata nelle questioni legate al cambiamento climatico. Per quanto riguarda i costi del cambiamento climatico, il 47 per cento delle intervistate e degli intervistati ha dichiarato che, secondo il principio del chi inquina paga, dovrebbero essere responsabili coloro che contribuiscono maggiormente al problema. Solo pochissime persone ritengono che chi è più colpito dalle conseguenze dovrebbe anche sostenere la maggior parte dei costi. È interessante notare che circa il 20 per cento sostiene che il cambiamento climatico non ha nulla a che fare con giustizia e disuguaglianza.
Kircher: Torniamo così all’analisi sociologica. Questo 20 per cento non considera la giustizia sociale come poco importante, al contrario. Eppure teme che ciò che sta loro a cuore venga messo in ombra da misure di politica climatica, e che le loro esigenze passino così in secondo piano. In relazione ai processi democratici, l’idealtipo diffidente si dimostra meno soddisfatto, reputando di avere poca autoefficacia politica.
"È necessaria una politica climatica ambiziosa, coerente e soprattutto partecipativa per rivitalizzare la democrazia e rafforzare la fiducia in essa."
Christoph Kircher
Differenze sociopolitiche tra i tre gruppi: la questione della democrazia
Come si potrebbe contrastare queste paure e rafforzare l’autoefficacia?
Kircher: Una misura potrebbe essere l’istituzione di un consiglio per il clima. In Alto Adige ne esiste già uno e i primi risultati dovrebbero essere presentati a breve. Il nostro studio mostra che è imprescindibile discutere le tematiche relative al clima in un contesto politico-democratico. È necessaria una politica climatica ambiziosa, coerente e soprattutto partecipativa per rivitalizzare la democrazia e rafforzare la fiducia in essa. Un consiglio per il clima ha lo scopo di invitare persone dalla società civile a discutere di un problema. Le esperte e gli esperti vengono coinvolti per fornire conoscenze sulla problematica e proporre diverse soluzioni. Successivamente, il consiglio per il clima discute la direzione da intraprendere. Dalla combinazione tra input scientifico e discussione civile possono emergere linee guida da rivolgere alla politica.
Windegger: Per includere effettivamente tutti i gruppi, sarà necessaria una notevole abilità organizzativa. È fondamentale avvicinarsi attivamente alle persone e considerare fin dall’inizio, quando si vanno ad attuare misure concrete, meccanismi di compensazione sociale ed economica.
 technical documentation
technical documentationL’indagine − contesto e metodologia
L’indagine “Così pensa l’Alto Adige: Emozioni e disuguaglianze nella crisi climatica” è frutto della collaborazione tra Eurac Research e l’Istituto provinciale di statistica ASTAT ed è stata condotta nell’estate del 2023 su 1.028 cittadine e cittadini della Provincia autonoma di Bolzano Alto − Adige. Il sondaggio è stato condotto su un panel probabilistico e pertanto consente di trarre conclusioni sulla popolazione nel suo complesso. L’analisi dei dati per differenziare i tre gruppi sociali è stata condotta attraverso l’analisi fattoriale. Si tratta della seconda collaborazione tra il Center for Advanced Studies di Eurac Research e l'Istituto provinciale di statistica ASTAT nell’ambito del panel ASTAT “Così pensa l'Alto Adige”. I risultati dettagliati sono disponibili per il download:
 technical documentation
technical documentationNota informativa
La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate.
Titolo del Sondaggio: Emozioni e disuguaglianze nella crisi climatica
1. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: ASTAT, Bolzano
2. Nome del committente e dell’acquirente: Eurac Research
3. Estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale): Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (provinciale)
4. Consistenza numerica del campione di rispondenti, numero o percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: Consistenza numerica del campione di rispondenti: 1.028, Rifiuti: 119
5. Data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio: 2023
6. Indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all’art. 5 del Regolamento di cui sopra: documentazione AGCOM
In ottemperanza all’art. 4 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010.