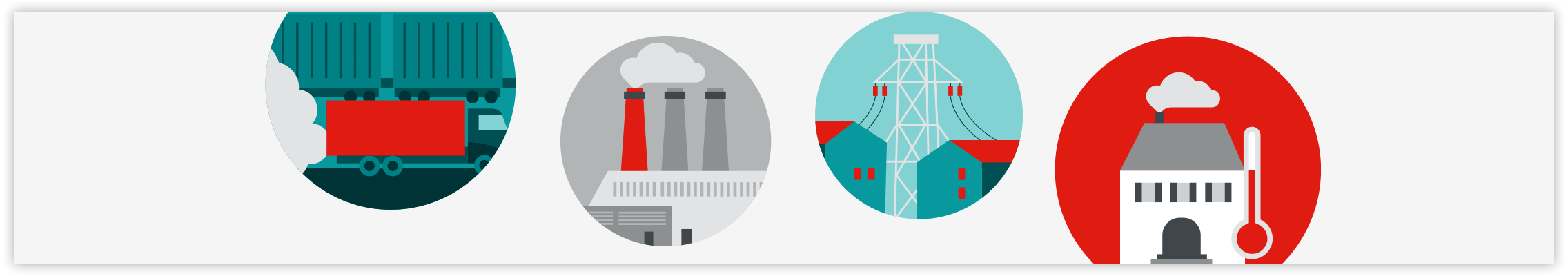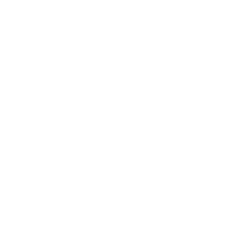magazine_ Article
Un pozzo non basta
Un caso studio in Angola racconta come nell’adattamento ai cambiamenti climatici la tecnologia da sola non sia sufficiente, anzi a lungo termine può far danni.
Nel contrasto alla siccità nell’Africa sub-sahariana, costruire infrastrutture idriche sul territorio – senza però usare determinate accortezze – potrebbe rendere la popolazione più stanziale ed erodere così preziosi saperi tradizionali su cui per secoli si è fatto affidamento per adattarsi a eventi estremi siccitosi. Pur alleviando il problema nel breve termine, le conseguenze a lungo termine potrebbero essere più negative che positive. È quanto evidenziato da uno studio dell’Università di Firenze ed Eurac Research.
Periodi di siccità estrema colpiscono milioni di persone dedite alla pastorizia nell’Africa subsahariana causando morti, carestie e migrazioni. Dopo dieci anni di caldo e siccità prolungata, l’anno 2022 è stato per la macroregione una dei più secchi mai registrati. In Angola del Sud ad esempio si parla della peggiore crisi ambientale degli ultimi 40 anni: fiumi scomparsi, terreni polverosi e spaccati dall’arsura, pascoli bruciati.
Una delle soluzioni adottate per aiutare la popolazione locale da parte di governi e organizzazioni non governative è la costruzione di piccole infrastrutture idriche in grado di portare in superficie l’acqua necessaria per il sostentamento della popolazione, del bestiame e dei campi coltivati. ONG, volontari e governi lavorano insieme per costruire pozzi, bacini di raccolta e piccoli laghetti necessari per praticare agricoltura e pastorizia.
Proprio in Angola meridionale e in una di queste campagne di costruzione di pozzi nel 2021 è stato coinvolto Luigi Piemontese, ricercatore dell’Università di Firenze esperto di gestione dell’acqua. Il progetto di cooperazione allo sviluppo aveva l’obiettivo di aiutare la popolazione locale costituita prevalentemente da pastori nomadi a sopravvivere in condizioni di forte siccità.
Affrontare la siccità: saperi tradizionali o espedienti tecnologici?
Pozzi e altre piccole infrastrutture idriche – in gergo SWI o small water infrastucture – sono costruiti solitamente in risposta a grandi episodi di siccità e hanno chiari benefici immediati: in sostanza permettono alla popolazione di sopravvivere senza doversi spostare verso altri luoghi meno aridi.
In inglese una soluzione di questo tipo viene chiamata tech-fix, un espediente tecnologico per risolvere un problema. Ed è anche per questo che è coinvolto Luigi Piemontese: il suo compito è quello di individuare i luoghi più adatti per la costruzione di queste infrastrutture. Così il ricercatore inizia a viaggiare attraverso lo sterminato paesaggio arido che contraddistingue il sud del paese, in direzione del deserto del Namib – arido da oltre 80 milioni di anni e ritenuto uno dei deserti più antichi del mondo. È questa anche l’occasione per conoscere il sapere tradizionale delle popolazioni nomadi: conoscenze sedimentate e tramandate che arrivano dall’esperienza accumulata.
Cosa succede quando il pozzo attorno a cui si è stabilita una popolazione più stabile si esaurisce?
“Affrontare gli eventi estremi siccitosi e i cambiamenti climatici si può fare in diversi modi. Quello che hanno usato finora le popolazioni del sud dell’Angola è il nomadismo,” spiega Luigi Piemontese. Le popolazioni locali tendenzialmente sanno dove spostarsi quando la siccità colpisce il territorio per poter trovare acqua. “Nel territorio infatti c’è un certo gradiente di siccità, ci sono aree estremamente aride dove – soprattutto in caso di siccità prolungata – non c’è alcuna possibilità di praticare alcuna attività di sostentamento come l’agricoltura o la pastorizia. Ci però zone meno aride dove periodicamente compaiono le condizioni per piantare qualcosa e far pascolare il proprio bestiame”.
Sono la conoscenza delle vie dove migrare e la propensione a spostarsi frequentemente ad aver permesso alle popolazioni locali di sopravvivere per secoli in un territorio così arido e soggetto a eventi di caldo estremo. La costruzione di pozzi è un altro modo di affrontare la siccità e sicuramente ha benefici immediati maggiori rispetto al nomadismo: la tribù non deve spostarsi, ma ha a disposizione l’acqua necessaria per i greggi e anche per praticare agricoltura di sostentamento. Durante le sue visite nei villaggi, Luigi Piemontese si accorge di un’altra conseguenza della costruzione dei pozzi: la popolazione attorno al pozzo diventa molto più stanziale, cosa – tra le altre cose – è anche molto apprezzata dal governo centrale del paese che in questo modo può almeno contare e controllare meglio la sua popolazione.
Ma cosa succede quando il pozzo costruito – attorno a cui si è stabilita una popolazione stanziale – si esaurisce? O se si manifesta un evento di caldo estremo ancora maggiore?
Il ricercatore poteva solo intuirlo sulla base della sua esperienza sul campo. La letteratura scientifica non offriva studi dettagliati riguardo le conseguenze della costruzione di piccole infrastrutture idriche per risolvere il problema della siccità estrema. Così il ricercatore dell’Università di Firenze chiede aiuto a Stefano Terzi, ingegnere delle acque di Eurac Research, per studiare più a fondo la faccenda. Insieme costruiscono un modello più olistico, in grado di analizzare le possibili conseguenze a lungo termine delle attività sul campo.
La dinamica dei sistemi per studiare le conseguenze della costruzione di pozzi contro la siccità estrema
Per costruire il modello i ricercatori si rifanno ad una metodologia di analisi chiamata “system dynamics”, la dinamica dei sistemi. Questo approccio si usa per capire il comportamento di un sistema complesso nel corso del tempo. Un sistema complesso può essere un fluido particolarmente bizzarro, l’atmosfera terrestre, uno stormo di uccelli e, anche, l’adattamento al cambiamento climatico da parte di una popolazione.
“Si tratta di schemi che mettono insieme i diversi pezzi del complicato puzzle che è la realtà. E ci aiutano a cercare relazioni controintuitive, conseguenze nascoste ed eventi che portano il sistema lontano dal suo punto di equilibrio,” spiega Stefano Terzi. “Questi modelli vengono nutriti con dati, e noi ne abbiamo usati molti e diversi: immagini satellitari, dataset globali e forniti dai governi locali, trend dalla letteratura scientifica. E abbiamo parlato con le persone del luogo intervistando le comunità pastorali”.
Questo approccio ha permesso al team di evidenziare diverse cose. Uno dei risultati ad esempio è la correlazione tra la costruzione dei pozzi e l’aumento della stanzialità, mostrata anche dalle immagini satellitari: dove si sono costruiti i pozzi sono aumentate le aree coltivate e diminuite invece le aree di pascolo.
“La dinamica dei sistemi ci permette di mettere insieme i diversi pezzi del complicato puzzle che è la realtà, trovando anche delle conseguenze nascoste”
“La stanzialità ovviamente non è una cosa negativa in sé. Ma ha delle conseguenze, soprattutto se praticata a lungo in un territorio estremamente siccitoso come alcune zone nel sud dell’Angola,” spiegano Stefano Terzi e Luigi Piemontese. “Aumenta così il consumo di risorsa idrica e se questi pozzi non riusciranno a soddisfarla – perché si esauriranno o per l’arrivo di un’ulteriore, ancora più marcata ondata di siccità – la popolazione che si era affidata a questa soluzione potrebbe trovarsi in guai più seri di prima”. C’è infatti il rischio che nel frattempo abbia perso la propensione a spostarsi verso aree con più acqua, anche perché nel frattempo hanno investito economicamente in quel luogo. Possono anche aver perso le conoscenze per spostarsi, i cosiddetti saperi tradizionali. In definitiva, quindi la costruzione di pozzi senza ulteriori accortezze o una governance consapevole, sebbene migliori la situazione nell’immediato, potrebbe peggiorare le condizioni di vita nel medio-lungo termine.
Tecnologia, governance e saperi tradizionali
Studi di questo tipo evidenziano come quando si affrontano tematiche complesse come i cambiamenti climatici debbano essere tenute in conto anche le conseguenze di lungo periodo e quelle più inaspettate.
“Ovviamente non si deve smettere di costruire infrastrutture idriche in quei luoghi,” spiegano Luigi Piemontese e Stefano Terzi, “ma è necessaria anche una governance che inserisca questi espedienti tecnologici in un contesto più ampio. Un contesto che coinvolga anche variabili sociali – come ad esempio il mantenimento del sapere tradizionale”.
Una serie di accortezze e una maggiore consapevolezza sia da parte di chi promuove l’intervento sia della popolazione locale sono necessarie affinché la tecnologia a disposizione non cambi il modo di vivere delle tribù nomadi pastorali. Il nomadismo rimane – guardando la cosa nell’ottica del lungo termine – probabilmente la strategia migliore di adattamento alla siccità in quella zona facendo in modo di non esaurire le risorse idriche in un pozzo e di permettere alle falde di ricaricarsi.
“Se non hai la governance rischi di rinforzare conseguenze negative che a lungo andare possono essere distruttive della resilienza della popolazione. La realizzazione delle infrastrutture dovrebbe invece essere accompagnata da una serie di accortezze per evitare che la tecnologia cambi il modo di vivere della popolazione,” suggeriscono i due ricercatori.
“Per esempio aiuterebbe limitare la quantità di pozzi realizzati e la loro densità per evitare che possano essere un incentivo alla stanzialità, oppure avere l’accortezza di realizzarli seguendo le rotte già sfruttate dai pastori nelle loro migrazioni interne”, concludono.
 technical documentation
technical documentationIl paper scientifico sulla rivista scientifica Nature
Il paper scientifico dal titolo “Over-reliance on water infrastructure can hinder climate resilience in pastoral drylands” è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Nature Climate Change. È disponibile ad accesso libero qui. Ad aver firmato il paper, oltre a Stefano Terzi di Eurac Research, sono Luigi Piemontese, Giuliano Di Baldassarre, Diego A. Menestrey Schwieger, Giulio Castelli ed Elena Bresci.