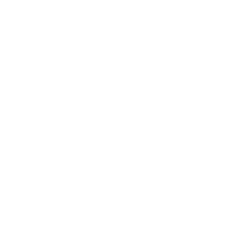Che differenza c’è tra sesso, genere e orientamento sessuale? Le donne hanno davvero meno opportunità degli uomini anche in una regione benestante come l’Alto Adige? Cosa è il linguaggio inclusivo? Questo dossier di Eurac Research tocca in forma di domanda e risposta i principali dubbi attorno al tema del genere.
- C’è differenza tra sesso e genere?
- Cosa sono gli studi di genere?
- È vero che l’ideologia gender vuole negare i sessi?
- Cosa è l’intersezionalità?
- Tante persone nelle società occidentali benestanti hanno la convinzione che i generi abbiano grosso modo parità di diritti. È così?
- Il circolo vizioso tra lavoro e cura della famiglia sembra senza soluzione…
- Cosa è il linguaggio inclusivo?
- Esempi di strategie per un linguaggio inclusivo
- Che differenza c’è tra femminicidio e omicidio?
- La violenza di genere è una questione di cultura?
- Le donne costituiscono circa la metà della popolazione mondiale. In politica però i numeri non tornano…
- Che rapporto c’è in Alto Adige con il femminismo e con i movimenti LGBTQIA+?
Contents
Scarica qui il Dossier Gender in formato PDF.
Gli spunti contenuti in questo dossier sono tratti dal “Gender Report – Alto Adige 2024”, a cura di Alexandra Tomaselli, Katharina Crepaz Mirjam Gruber e redatto da oltre 40 autrici e autori di Eurac Research e non solo.
C’è differenza tra sesso e genere?
Il sesso cosiddetto “biologico”, maschile o femminile, è quello attribuito alla nascita essenzialmente sull’osservazione dei genitali esterni. Si chiama “sesso assegnato alla nascita”. L’identità di genere è invece come si sente una persona: femmina, maschio, non-binaria, fluida o altro ancora. Queer è un modo per raccogliere le diversità di genere. La sociologa britannica Ann Oackley è stata una delle prime a descrivere questa differenza negli anni Settanta.
Se una persona sente che il sesso assegnato alla nascita e identità di genere combaciano si parla di persona cisgender, per esempio sesso maschile con identità di genere maschile. Se sono diversi si tratta di una persona transgender o non-binaria, per esempio una donna transgender, sebbene abbia il sesso assegnato alla nascita di tipo maschile, sente una identità di genere femminile. Il disagio provato dall’incongruenza tra sesso assegnato alla nascita e identità di genere si chiama disforia di genere. La affermazione o transizione di genere è invece il percorso che affrontano le persone transgender per trovare corrispondenza e vedersi riconosciuta pubblicamente la propria identità di genere. Al momento per la legge italiana non è più necessario un intervento chirurgico ai genitali esterni o una terapia ormonale per cambiare nome e identità anagrafica.
Attenzione: il genere non è determinato solo dai genitali esterni, ci sono tante caratteristiche sessuali come gli ormoni, i cromosomi e altri tratti anatomici secondari (per esempio il pomo d’Adamo, il seno, ecc.). Circa una persona su 60 presenta delle variazioni di queste caratteristiche: la comunità medica le definisce “intersessuali”.
L’orientamento sessuale è un altro discorso. Ci sono persone eterosessuali, omosessuali, bisessuali o assessuali, aromantiche o altro. Quindi, per esempio, una donna transgender può essere eterosessuale se attratta da uomini oppure omosessuale se attratta da altre donne.
Se sesso assegnato alla nascita e identità di genere combaciano si parla di persona cisgender, se sono diversi si parla di persona transgender o non-binaria.
Cosa sono gli studi di genere?
Gli studi di genere, noti anche con il termine inglese gender studies, sono una disciplina scientifica nata nella seconda metà del XX secolo che studia in modo interdisciplinare tutti i temi e gli aspetti in cui la categoria del genere diventa socialmente rilevante. Chi si occupa di studi di genere parte dal presupposto che attribuire determinate caratteristiche e inclinazioni alle persone sulla base del loro sesso non è corretto; piuttosto, è la socializzazione in ruoli spesso stereotipati che porta alle differenze. Quindi, le disuguaglianze si potrebbero superare rafforzando modelli diversi. Per esempio potrebbe diventare molto più normale che gli uomini si occupassero dei lavori di cura, sia professionalmente come educatori negli asili nido o assistenti alle persone anziane, sia in ambito familiare. Gli studi di genere raccolgono dati e ragionano su alternative di convivenza e collaborazione tra generi, in modo che i singoli individui si sentano a proprio agio e la società nel complesso superi le discriminazioni e riconosca gli stessi diritti a ogni persona.
Gender studies e attivismo sono due ambiti differenti, anche se possono influenzarsi a vicenda.
Solo dal 1993 le donne devono essere incluse negli studi clinici. Prima l’unico modello di riferimento era il corpo maschio cisgender.
È vero che l’ideologia gender vuole negare i sessi?
No. Intanto bisogna precisare che “ideologia gender” è una definizione usata da chi contesta gli studi di genere, lasciando intendere che esista un piano per distruggere l’idea di società e famiglia tradizionale. È una espressione nata negli ambienti dell’estrema destra e che ora viene usata in modo più ampio, ma una ideologia gender non esiste perché gli studi di genere non sono un credo, ma una disciplina scientifica. Ciò detto, in realtà gli studi di genere non negano il sesso “biologico” e, anzi, ritengono fondamentale studiare meglio e raccogliere più dati sulle differenze tra sessi in senso sia sociale, sia biologico. Finora il corpo del maschio cisgender è stato l’unico modello di riferimento e questo ha provocato e provoca molti problemi. Per esempio è solo da trent’anni, dal 1993, che le donne devono essere incluse negli studi clinici. Prima si riteneva che le mestruazioni intralciassero i risultati, ma oggi si sa che, anche proprio per il ciclo e i cambiamenti ormonali, i farmaci agiscono in modo diverso su uomini e donne, per cui per farli funzionare meglio è importante che siano studiati in modo mirato. Lo stesso vale per i test di sicurezza sugli autoveicoli, che venivano fatti solo sulla base del corpo maschile: poiché generalmente l’uomo ha misure e organi posizionati diversamente, in caso di scontro un dispositivo di sicurezza pensato per un corpo maschile potrebbe non essere altrettanto sicuro per una donna.
Cosa è l’intersezionalità?
In generale le difficoltà e le discriminazioni tendono non solo a sommarsi, ma a influenzarsi e ingarbugliarsi in circoli viziosi specifici, le cosiddette “intersezioni”, molto difficili da rompere. Per esempio le persone transgender affrontano un forte stigma nella vita quotidiana; se hanno un background migratorio si aggiunge il fatto che spesso vengono automaticamente identificate come sex worker (cioè come persone che si prostituiscono) anche quando non lo sono, e questo rende la loro vita ancora più faticosa. Un altro esempio più comune: le donne anziane che vivono sole sono più a rischio di povertà rispetto ai coetanei maschi nelle stesse condizioni perché in generale le loro pensioni sono più basse; infatti di norma le donne accantonano meno contributi da lavoro retribuito perché si sono dedicate al lavoro di cura familiare.
Avere un approccio intersezionale vuol dire tenere in considerazione tutti gli elementi che provocano situazioni di discriminazione, studiare come si influenzano e fare proposte per risolverli. I fattori che più spesso entrano in gioco sono il genere, lo status economico, l’etnia o la propria provenienza e ciò che ne consegue (per esempio il razzismo), l’orientamento sessuale, le disabilità, la religione, l’età.
Il femminismo intersezionale è un movimento che non si concentra solo sui diritti delle donne e delle altre minoranze di genere ma si apre ad altre battaglie, per esempio quelle per la tutela dell’ambiente, contro le discriminazioni basate sulla disabilità, ecc.
La metafora dietro al concetto di intersezionalità

Il concetto di intersezionalità è stato formulato dalla giurista Kimberlé Crenshaw che usa la metafora di un incrocio stradale. Secondo il suo ragionamento, come il traffico a un incrocio può arrivare da quattro direzioni diverse, anche la discriminazione ha varie origini. Così come un incidente può essere provocato dal flusso che arriva da un lato qualsiasi ma anche coinvolgere i mezzi che arrivano da tutte le direzioni contemporaneamente, allo stesso modo se una donna nera viene ferita a un “incrocio” la causa potrebbe essere sia la discriminazione sessista che quella razzista.
Tante persone nelle società occidentali benestanti hanno la convinzione che i generi abbiano grosso modo parità di diritti. È così?
Purtroppo il punto debole sta nel “grosso modo”. Anche se può sembrare ripetitivo, l’esempio del mondo del lavoro è molto chiaro. Al momento l’Islanda e la Norvegia sono gli unici stati al mondo dove il gender employment gap (divario occupazionale di genere) si considera pressoché chiuso, cioè gli unici stati dove donne e uomini hanno quasi sempre le stesse opportunità lavorative. Negli altri paesi le donne si concentrano in determinati settori professionali (di norma legati all’educazione o all’assistenza), guadagnano meno a parità di mansioni o non riescono a raggiungere posizioni ai vertici. Anche in Alto Adige, una provincia in cui le cose vanno decisamente meglio che altrove, il problema si sente: secondo i dati ASTAT nell’anno scolastico 2021/22 circa il 75 per cento delle ragazze ha frequentato una scuola superiore contro il 63 per cento dei ragazzi. Anche il tasso di frequenza universitaria e di laurea è significativamente più alto per le donne. Eppure sui luoghi di lavoro le proporzioni non tornano. Tre esempi.

Persino nell’amministrazione provinciale, un contesto molto sorvegliato dove ci sono misure antidiscriminazione chiare e forti, al 31 dicembre 2022 solo circa il 30 per cento dei posti dirigenziali era occupato da donne, che però sono il 70,4 per cento del totale impiegato.

In un territorio come l’Alto Adige in cui l’agricoltura è un settore importante solo da poco più di vent’anni le donne hanno pari diritti degli uomini nella linea ereditaria del maso chiuso (azienda agricola indivisa). E comunque prevale ancora la conduzione maschile: nel 2016, solo il 13,5 per cento delle aziende agricole era gestito da donne contro il dato nazionale del 30,7 e quello europeo del 27,9 per cento.

Anche nelle principali istituzioni di ricerca dell’Alto Adige la presenza di donne diminuisce a mano a mano che si sale verso i vertici. In Eurac Research a capo degli 11 istituti e dei sei center ci sono 14 uomini e tre donne; in università le cattedre occupate da professoresse sono il 31 per cento; nel Centro di sperimentazione Laimburg il personale è suddiviso al 50 per cento tra uomini e donne, ma la percentuale di donne alla guida di gruppi di lavoro si ferma al 34,1 per cento.
Vuole dire che le donne sono sempre sacrificate sul lavoro? Oppure sono meno determinate, fanno scelte di vita diverse? Non può esserci una risposta netta. C’entrano diverse spiegazioni. Tanto gira attorno al fatto che le donne si fanno carico – senza che sia riconosciuto e non sempre per libera scelta – della maggior parte del lavoro di cura delle famiglie: bambini, assistenza agli anziani, organizzazione delle attività, delle ferie, ecc. Da una parte chi fa impresa si fa scrupoli ad assumere donne o a offrire loro un ruolo chiave – e dunque meglio retribuito – temendo che faranno più assenze. Dall’altra parte le donne spesso sono le sole a chiedere – o si sentono obbligate a prendere – il congedo parentale o il part-time per seguire la famiglia, allontanandosi sempre più dal mondo del lavoro e riducendo anche le proprie prospettive sia di carriera, sia economiche. Il 70 per cento delle 3-400 richieste annuali al Servizio antimobbing dell’Alto Adige sono di donne che si sentono penalizzate al rientro dopo la maternità o dopo i 45 anni, quando cominciano a dover chiedere più permessi per assistere i genitori.
Nei referti radiologici delle donne le descrizioni del dolore vengono spesso rese in modo più approssimativo.
Il circolo vizioso tra lavoro e cura della famiglia sembra senza soluzione…
Senz’altro non è semplice perché si tratta di un sistema così radicato che servono cambiamenti profondi, strutturali. In Italia dal 2019 è aumentato il numero assoluto di padri che prendono il congedo parentale, ma per un tempo medio molto più breve: 23 giorni rispetto ai 78 delle madri. Nella Provincia autonoma di Bolzano il 95,6 per cento dei giorni di assenza per genitorialità è richiesto dalle donne. Secondo i dati ASTAT, in Alto Adige, a fronte di solo due padri su dieci, sei madri su dieci prendono aspettativa e tante chiedono il part-time. Spesso si motiva la scelta con il fatto che in una coppia eterosessuale è più conveniente che sia l’uomo a mantenere il lavoro a tempo pieno perché pagato meglio. Anche lo stigma sociale e la scarsa accettazione del ruolo dell’uomo come caregiver, ossia come principale incaricato del lavoro di cura familiare, giocano un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda l’assistenza alle persone anziane o malate ci sono meno dati ufficiali; l’organizzazione familiare è ancora più informale e il lavoro non retribuito meno visibile, ma si può ipotizzare che il discorso sia lo stesso. Si potrebbe fare diversamente? Sicuramente una rete capillare ed efficace di servizi è indispensabile.
In altri paesi ha funzionato anche stabilire dei tempi minimi per il congedo parentale dei padri. Questo assicura infatti che gli uomini possano assumersi responsabilità di cura nonostante la pressione sociale, e chi assume si trova a ripensare le politiche di assunzione e promozione. Per esempio in Svezia, già dal 1974, il congedo è di 480 giorni (16 mesi) in totale: ogni genitore può prendere 90 giorni per sé, mentre i restanti 300 giorni possono essere divisi in modo flessibile. A oggi, il 76 per cento dei padri prende il congedo parentale, la maggior parte tra sei e nove mesi. Un’altra via per far vedere la possibilità di un sistema diverso e poi metterlo in pratica è lavorare sull’educazione: per esempio sollevare già le bambine dall’idea che sia una vocazione di tutte loro quella di prendersi cura degli altri e insegnare ai bambini che chiunque deve dedicarsi ai compiti casalinghi. Tuttavia questo non è semplice e richiede tempo e molta attenzione. Da uno studio di Eurac Research (KiDiLi) è emerso che educatrici ed educatori nelle scuole d’infanzia di lingua tedesca si orientano ripetutamente verso immagini di genere tradizionali nonostante gli sforzi attivi per abbattere gli stereotipi.
Tutte queste iniziative hanno in comune una cosa: l’importanza di informare e di rompere gli stereotipi di genere. Ne possono beneficiare per primi gli uomini che potrebbero godersi di più la famiglia o comunque non sentirsi costretti nella figura classica della mascolinità.
Cosa è il linguaggio inclusivo?
Un linguaggio inclusivo rappresenta in modo equo tutti i generi, e in generale tutte le diversità. Da una parte le parole rendono reali cose che non esistono se non nominate; dall’altra parte l’uso di certe parole invece di altre influenza la rappresentazione che abbiamo dei ruoli di genere. Due esempi.
A 636 studenti e studentesse delle scuole superiori di lingua italiana in Alto Adige è stato chiesto di definire la professione dei genitori. In alcuni casi si è notata una certa creatività nell’espressione dei femminili di professione, come in “imprenditora”, e segnali di dubbi linguistici per femminili poco frequenti nell’uso, con il ricorso a combinazioni interessanti come “medico chirurga”. Del resto, “medica” o “architetta” suoneranno sempre come parole strane finché non entreranno nell’uso comune. In 75 casi si è descritta la professione di entrambi i genitori al maschile (uno è “imprenditore” e l’altro è “avvocato”): potrebbero essere tutte coppie omogenitoriali, oppure la componente femminile potrebbe essere stata oscurata da un maschile sovraesteso.
A Innsbruck un gruppo di ricerca universitario ha analizzato cinque milioni di referti radiologici compilati tra il 2007 e il 2019. All’apparenza sono simili e standardizzati, ma un’analisi più approfondita rivela, per esempio, che nei referti delle donne compaiono più spesso diminutivi, come “cistina”, che possono portare le pazienti a ricevere meno accertamenti. Questo aspetto linguistico va a braccetto con il fatto che le descrizioni del dolore vengono spesso rese in modo più approssimativo, quasi a sostegno dello stereotipo della donna “complicata”. Vari studi internazionali hanno constatato che le rappresentazioni stereotipate di genere possono avere conseguenze dannose per la salute: gli uomini ricevono troppo raramente assistenza per problemi psicologici, mentre le sofferenze fisiche delle donne vengono spesso psicologizzate e minimizzate.
Esempi di strategie per un linguaggio inclusivo
Oramai anche in Alto Adige molte istituzioni, organizzazioni e aziende si sono dotate di linee guida per un linguaggio inclusivo, sebbene non tassative. Ci sono varie opzioni.

Strategie lessicali come lo sdoppiamento, per esempio “alunni e alunne”, oppure nomi collettivi o impersonali, per esempio “la cittadinanza” invece dei “cittadini”, oppure “le voci critiche” invece di “i critici”.

Strategie sintattiche come le frasi relative, per esempio “chi studia” invece di “gli studiosi”.

Simboli. In italiano si può usare l’asterisco (per esempio “ciao a tutt*”) oppure lo schwa (per esempio “lə cittadinə” intesa come forma singolare non-binaria, oppure “tutte lɜ cittadinɜ”, al plurale) per evitare di privilegiare un genere e includere anche le persone non-binarie. In tedesco si usano l’asterisco di genere * , i due punti, il trattino basso, la barra, o anche l’Entgendern (cioè il superamento del gender) con la “y” (per esempio die/der Lehrer/in = das Lehry). Questi simboli tuttavia potrebbero escludere coloro che hanno difficoltà di lettura e scrittura.
Usare il maschile sovraesteso potrebbe sembrare più comodo per chi scrive, ma rischia di creare problemi di comprensione e ovviamente suscita disagio in chi non ci si riconosce. Un esempio di ambiguità si ha quando il maschile viene usato per riferirsi sia solo agli uomini, sia a persone di tutti i generi. La frase “nella scuola dell’infanzia ci sono pochi educatori” non permette di capire se ci sono pochi educatori uomini o poco personale in generale. Per provare invece come si sentono alcune persone leggendo testi in cui il maschile è riferito a tutte le persone, si può leggere il nuovo Regolamento generale di ateneo dell’Università di Trento scritto tutto al femminile, anche quando ci si riferisce a cariche attualmente ricoperte da uomini.
Gli uomini violenti strumentalizzano i codici morali e religiosi per giustificare il loro comportamento.
Che differenza c’è tra femminicidio e omicidio?
Il femminicidio è un omicidio che nasce in un preciso contesto socioculturale patriarcale: un ambiente in cui domina l’idea che l’uomo abbia il diritto di controllare lo spazio di azione di una donna, fino all’estremo di decidere della sua vita. Il femminicidio è solo la punta dell’iceberg di una violenza di genere che si esprime più spesso in forma di violenza sessuale, psicologica, per esempio controllo delle uscite, dei contatti e del telefono, o economica, per esempio controllo dei soldi in casa, divieto di lavorare, ecc. I dati diffusi dall’ASTAT mostrano che nel corso del 2022 i quattro centri antiviolenza dell’Alto Adige hanno accolto 600 donne (+2,3 per cento rispetto all’anno precedente) e hanno erogato 5.350 prestazioni, in particolare in risposta a richieste di informazioni e consulenze. Secondo le operatrici dei centri, il fenomeno sarebbe in aumento: nel 2023, in Alto Adige, oltre a un gran numero di interventi delle forze di polizia, si sono registrati anche due femminicidi.
La Convenzione di Istanbul è il più importante strumento giuridico per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: è stato ratificato però solo da 39 stati, tra cui l’Italia.
Nel 2006 il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri italiana ha attivato il 1522, numero gratuito di pubblica utilità attivo 24 ore su 24. Il servizio, disponibile in diverse lingue, garantisce l’anonimato alle vittime di violenza, può fornire consigli su come ottenere assistenza per uscire da situazioni di violenza e attivare forme di intervento rapido nei casi di emergenza grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine.
La violenza di genere è una questione di cultura?
Vorrebbe dire che ci sono culture, aree geografiche o religioni più propense alla violenza di genere, ma gli studi dimostrano che non c’è un’evoluzione lineare della condizione femminile; piuttosto questa viene influenzata dalla situazione economica e politica. Per esempio, nell’Afghanistan urbano, negli anni Ottanta, le donne studiavano, lavoravano e le si vedeva per strada in minigonna con i capelli sciolti. Chi si occupa di violenza sulle donne definisce culturizzazione della violenza la giustificazione per cui la violenza di genere sia più “normale” per alcuni gruppi di persone, generalmente chi ha un background migratorio. In una intervista rilasciata a Eurac Research, Marina Della Rocca, ricercatrice con una lunga esperienza da operatrice, spiega che talvolta cade in questa tentazione persino chi opera nei centri antiviolenza, quando prevale la frustrazione più profonda di fronte a situazioni che sembrano senza via d’uscita. Della Rocca ricorda però che le donne migranti che ha intervistato “sono ben consapevoli del fatto che gli uomini violenti strumentalizzano i codici morali e religiosi per giustificare il loro comportamento”.
Le donne costituiscono circa la metà della popolazione mondiale. In politica però i numeri non tornano…
Le donne sono nettamente sottorappresentate, malgrado alcune misure prese per contrastare il fenomeno: a livello mondiale occupano meno di un terzo dei seggi parlamentari. Il Ruanda è il paese con la maggiore percentuale di donne nella camera dei deputati del parlamento (61,3 per cento), seguito da Cuba (53,4 per cento) e dal Nicaragua (51,7 per cento). L’Italia si trova al 56° posto con il 32,3 per cento di donne nella camera dei deputati, superando comunque la media mondiale del 26,5 per cento.
In Alto Adige le donne rappresentano la metà abbondante della popolazione eppure solo circa un comune su dieci è guidato da una sindaca e nel consiglio provinciale le consigliere non sono nemmeno il 30 per cento del totale.
Secondo chi si occupa di studi di genere questa sottorappresentazione influenza anche le agende politiche perché, di riflesso, alcune esperienze e sensibilità sono sottorappresentate.
Per esempio numerose indagini e studi internazionali hanno dimostrato che, solitamente, le donne hanno in media un livello più elevato di consapevolezza ambientale, una maggiore apertura verso stili di vita sostenibili e una maggiore disponibilità a impegnarsi nelle questioni ambientali. Anche da un sondaggio sulla sostenibilità e sui cambiamenti climatici in Alto Adige, condotto da Eurac Research e dall’ASTAT nel 2022, emerge che le donne sostengono che sia più necessario agire nell’ambito della tutela dell’ambiente e del clima rispetto ad altri ambiti. Per il 62,7 per cento si sta facendo troppo poco per la natura e gli ecosistemi in Alto Adige contro il 55,6 per cento degli uomini. Anche se è interessante notare che le donne ritengono più spesso degli uomini che la responsabilità principale per garantire una maggiore sostenibilità spetti ai singoli individui (e quindi anche a loro stesse). Gli uomini condividono la visione della responsabilità individuale, ma attribuiscono maggiore responsabilità alla politica e all’economia in generale.
Anche la pianificazione urbanistica verrebbe influenzata se politicamente fossero rappresentate più esperienze personali diverse: per esempio un questionario svolto in una valle periferica, a Selva dei Molini, ha rilevato come l’accompagnare altre persone nello svolgimento delle loro attività è un compito svolto al 92 per cento dalle donne, che hanno dunque esigenze molto diverse rispetto alla mobilità.
Come si potrebbero cambiare le cose? Per esempio promuovendo l’attivismo femminile nelle associazioni locali e in quelle di volontariato, spesso considerate un trampolino di lancio per la carriera politica delle donne.
Che rapporto c’è in Alto Adige con il femminismo e con i movimenti LGBTQIA+?
Come spesso accade nelle città di provincia l’attivismo è arrivato un po’ in ritardo, importato da persone che avevano vissuto altrove e si erano lasciate ispirare. Nel 1970 fu fondato il Gruppo Kollontaj, che prendeva il nome dalla socialista e femminista russa Aleksandra Kollontaj e che ha contribuito all’apertura nel 1973 del primo consultorio per donne della provincia, sezione locale dell’AIED (Associazione italiana per l’educazione demografica). Dalla metà degli anni Settanta si organizzarono le donne dell’Associazione cattolica dei lavoratori (Katholischen Verbands der Werktätigen, KVW) e si svilupparono gruppi femministi all’interno dell’Associazione universitaria sudtirolese e del giornale “Südtiroler Volkszeitung”. Nel 1979 fu fondato un gruppo di “Donne per la pace”, attivo a livello internazionale. Anche i partiti politici principali aprirono via via al loro interno gruppi femministi. L’associazione Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol, nata per contrastare qualsiasi discriminazione legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, è del 1993. Dal 1997 la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e il Servizio Donna pubblicano la rivista trilingue “ëres - fraueninfodonne”. Oggi una piattaforma piuttosto attiva è il gruppo Facebook SUSI: Südtirol Sisters. Dal 2023 esiste anche Alto Adige Pride Südtirol.
Una caratteristica del femminismo in Alto Adige è il fatto di saper sfruttare gli ambienti conservatori e anche religiosi ben radicati per fare rete e promuovere così temi tutt’altro che conservatori. L’Associazione delle donne coltivatrici sudtirolesi (Südtiroler Bäuerinnenorganisation), con circa 17mila iscritte, è la più grande organizzazione femminile del paese. E proprio alcune contadine hanno creato una cooperativa sociale che fornisce servizi di assistenza all’infanzia decentralizzati nei masi a oltre 500 bambini e bambine, dando lavoro a più di 100 donne. Tramite la cooperativa le contadine hanno dato valore imprenditoriale al tempo che prima impiegavano nel loro lavoro di cura non retribuito, rafforzando la capacità di negoziare il proprio ruolo. Anche la Katholische Frauenbewegung (Movimento delle donne cattoliche) ha grande peso; la Südtirols Katholische Jugend ha dedicato l’edizione 2022 della rivista “Hosch a Meinung?” (Hai un’opinione?) alla discussione sul sacerdozio femminile, la benedizione delle persone omosessuali e altre tematiche legate al genere.
Le quattro ondate del femminismo
1. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Rivendicazioni: accesso all’educazione superiore, diritto di voto.
2. Anni Sessanta e Settanta. Rivendicazioni: diritti riproduttivi, divisione equa dei compiti familiari, diritto al lavoro. Slogan: il privato è politico.
3. Anni Novanta. Internazionalizzazione del movimento, con accoglienza di istanze dal sud del mondo. Nel 1989 la giurista femminista afroamericana Kimberlé Crenshaw definisce il concetto di “intersezionalità”: l’attenzione va a chi si trova a un incrocio, all’intersezione di più condizioni o fattori sociali potenzialmente discriminanti, per esempio il genere, orientamento sessuale, il colore della pelle, una disabilità, una diversa appartenenza religiosa, povertà, ecc.
4. Dal 2012. Ulteriore internazionalizzazione attraverso i social media. Rivendicazioni: autodeterminazione del corpo e degli orientamenti sessuali contro la violenza sessuale e l’abuso di potere, lotta all’omofobia e alla fobia transgender. Slogan: #metoo, #nonunadimeno.
Non c’è un’evoluzione lineare della condizione femminile che viene piuttosto influenzata dalla situazione economica e politica.
- Research Across Institutes(all stories)
- Center for Migration and Diversity(all stories)
- Istituto sui diritti delle minoranze(all stories)
- Center for Advanced Studies(all stories)
- Istituto di linguistica applicata(all stories)
- Istituto per lo sviluppo regionale(all stories)
- Istituto per le energie rinnovabili(all stories)
- Istituto per l'osservazione della Terra(all stories)
- Center for Climate Change and Transformation(all stories)